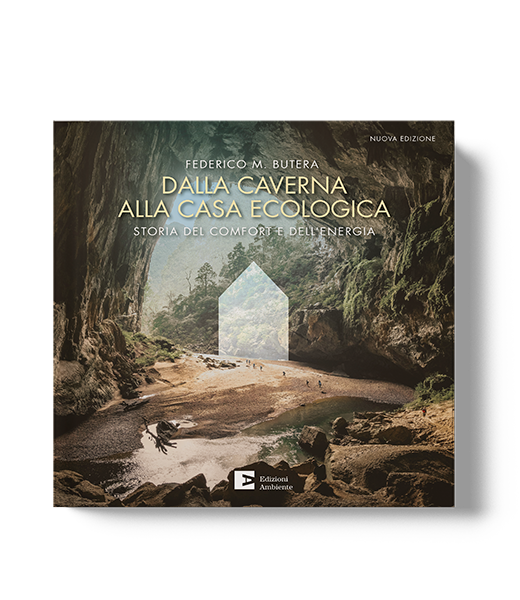Paesaggio e fonti rinnovabili: la nuova alleanza
Prologo
Si muovono con circospezione, silenziosi, nel sottobosco: sentono delle voci. A un certo momento si trovano allo scoperto, il bosco si interrompe bruscamente, sostituito da un’area priva di cespugli, alberi, macchie. Un’area terribile a vedersi, un maleficio: è piena solo di piante tutte uguali, geometricamente allineate (e quando mai prima?) e non ci sono conigli, lepri, volatili da cacciare perché non hanno un rifugio in cui nascondersi. Rientrano velocemente nel bosco, terrorizzati, e si allontanano il più rapidamente possibile: si sono trovati di fronte al primo cambiamento del paesaggio dovuto all’uomo, quello causato dall’agricoltura, una decina di migliaia di anni fa.
Dalla simbiosi alla sopraffazione
Era il trionfo dell’uomo sulla natura, ma non si trattava di sopraffazione, anche se si era partiti dalla distruzione di una foresta. Quelle geometrie erano il risultato di una coevoluzione dell’uomo e dell’ambiente, il risultato di una simbiosi fra l’uomo e le piante. A queste l’agricoltore garantiva difesa dagli animali che ne volevano mangiare i teneri germogli, danneggiandole, e forniva pure i nutrienti di cui le piante avevano bisogno per crescere bene, e l’acqua, altrettanto importante. In cambio, la pianta regalava all’uomo i suoi frutti. Una condizione conveniente per tutti, realizzata in modo da potere durare per sempre – essere sostenibile diciamo oggi – perché imitava alla perfezione il funzionamento degli ecosistemi naturali, riciclando sempre la stessa materia, le sostanze nutrienti che dal suolo passano alle piante, all’uomo, agli animali domestici e da questi cedute di nuovo al suolo come deiezioni; e, come negli ecosistemi naturali, usava solo fonti rinnovabili: il sole e il lavoro muscolare, umano e animale. L’uomo creò dunque un nuovo ecosistema, quello agricolo, che controllava e di cui garantiva il funzionamento, adattandosi alle leggi della natura. Con l’agricoltura di sussistenza si integrò nelle leggi della natura.
Grazie a questa coevoluzione nasce il paesaggio rurale, che quindi non è solo geometrie, quelle che si vedono, ma è anche l’ecosistema che dà vita al processo produttivo, le costruzioni che servono, le strade che collegano i campi ai centri abitati verso cui vengono avviati i prodotti, e da cui si riceve una parte dei nutrienti, e tutte le altre infrastrutture che sono legate alla commercializzazione dei prodotti agricoli, ma non solo. Certo, nel corso della storia non sono mancati gli esempi di sfruttamento estremo del suolo, impoverito fino al punto di renderlo improduttivo, spezzando così la circolarità di processi naturali, ma sono eccezioni limitate nel tempo.
Qualcosa cambia a partire da un paio di centinaia di anni fa, e in modo fortemente accelerato dal primo decennio del secolo scorso, quando in agricoltura ha inizio la sopraffazione, che si sostituisce alla simbiosi, alla coevoluzione. Le piante trattate come operai pigri, di cui occorre aumentare la produttività. Produttività che si aumenta intervenendo con nuovi mezzi di produzione, i fertilizzanti artificiali, i pesticidi, le macchine agricole, le varietà vegetali geneticamente selezionate. Produrre sempre di più – è l’ossessione – e dalla simbiosi si passa allo sfruttamento, dalla ciclicità alla linearità, dall’ecosistema agrario alla fabbrica di cibo che estrae sempre nuove risorse dall’ambiente, le usa e le getta.
L’impatto sul paesaggio
L’aumento della produttività in agricoltura, la cosiddetta rivoluzione verde, cioè la rivoluzione chimica e meccanica, ha avuto inevitabili effetti sul paesaggio.
Prendiamo ad esempio un paesaggio tanto decantato e amato dai turisti, il paesaggio rurale toscano, umbro, marchigiano. Vigneti, orti, frutteti, campi di grano, cascine e, magari, un borgo medievale sullo sfondo. Bello, siamo stati bravi, il paesaggio è rimasto uguale a quello di Dante, di Lorenzo De’ Medici. Lo vediamo pure dalle pitture del tempo. Peccato che non sia vero. Non è vero perché se apparentemente, alla vista, niente è cambiato, in realtà è completamente cambiato l’ecosistema agrario. Nel paesaggio di oggi non ci sono le stesse pratiche agricole, ci sono invece tonnellate di fertilizzanti artificiali, di pesticidi, non ci sono gli stessi insetti, le stesse erbe selvatiche, gli stessi uccelli, o almeno non nelle stesse proporzioni. Con uccelli diversi sono diversi i suoni, con i prodotti chimici al posto del letame sono diversi gli odori, e anche la salute ne risente. Ma non ce ne accorgiamo: non abbiamo conosciuto gli altri suoni e odori.
E c’è dell’altro: sono diverse molte delle piante coltivate. C’è il campo di pomodori, che al tempo dei Medici non esistevano; c’è il campo di mais, patate, zucche, tutti prodotti che arrivano dopo la scoperta dell’America.
Non è lo stesso paesaggio, non abbiamo preservato il paesaggio originale, anche se la percezione è che lo abbiamo fatto.
Della percezione del paesaggio e della sua realtà tiene conto la definizione che ne dà la Convenzione Europea del Paesaggio: “‘Paesaggio’ designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Quindi, le interazioni reciproche uomo-natura cambiano, ma la percezione che si ha di questo cambiamento dipende dal fatto che l’immagine del territorio e del suo funzionamento è filtrata attraverso il nostro modello culturale. E per effetto del filtro esercitato dal modello culturale un paesaggio che cambia è percepito migliore o peggiore di quello di prima, è accettato o rifiutato.
E qui nasce un problema che deriva dall’aggiornamento dell’articolo 9 della nostra Costituzione, secondo cui "la Repubblica... Tutela il paesaggio... Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni". Cosa succede quando la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e delle nuove generazioni si scontrano con la tutela del paesaggio, della sua percezione? Che succede quando un nuovo paesaggio tutela l’ambiente e il futuro di chi verrà dopo di noi meglio di quanto non lo faccia il vecchio, ma è percepito negativamente, come inaccettabile? Chi vince?
Due pesi e due misure
È già successo tante volte nella storia dell’uomo che la percezione del paesaggio cambi, più o meno velocemente, perché cambia qualcosa nel soggetto che lo percepisce. E così, con uno straordinario gioco di prestigio psicologico riusciamo a non vedere tralicci dell’alta tensione, le alte antenne che permettono ai nostri smartphone di funzionare, i ripetitori della televisione, le ingombranti macchine agricole. Tutto ciò non c’era prima. Il paesaggio è cambiato, è diverso da quello di prima, ma non lo abbiamo respinto: il nostro filtro culturale ha lasciato che tutti questi corpi estranei passassero attraverso le sue maglie senza generare rifiuto.
Bisogna dire che siamo ben strani. Ci sono stati periodi in cui un paesaggio definito da alte ciminiere, intrico di tubi, recipienti, tralicci, fumo, tanto fumo, era qualcosa di bello, segno di progresso, della grandezza dell’uomo. Raffinerie, acciaierie, impianti chimici, centrali elettriche, fabbriche di ogni genere, segno del progresso, altro che devastazione del paesaggio...Persino la pittura, nel realismo socialista, si fece interprete di questa visione. Infiniti gli esempi. Senza fare tanti riferimenti storici, basti pensare al giubilo iniziale con cui furono salutate le raffinerie di Priolo e di Gela in Sicilia, giusto per citarne un paio, oggi considerate come dei bubboni paesaggistici, ma che allora venivano fotografate con orgoglio e soddisfazione. E intanto il mare, gli ecosistemi, la salute degli uomini venivano irrimediabilmente compromessi. Ci furono resistenze, proteste, quelle dei contadini che furono cacciati o la cui produzione veniva avvelenata, ma erano visti come nemici del progresso, e poi c’erano i nuovi posti di lavoro creati a fare chiudere gli occhi sul nuovo terribile paesaggio, e nessuna soprintendenza al mondo avrebbe mai osato opporsi alla crescita economica.
Veniamo ai nostri giorni. Se si prova a viaggiare sull’autostrada fra Palermo e Trapani ci si imbatte in diversi campi eolici, alcuni vicini, altri più lontani. Orrore. Paesaggio devastato. Già, orrore, ma non si percepisce minimamente l’orrore paesaggistico del nastro di autostrada che si stende per chilometri e chilometri davanti e dietro di noi con viadotti, gallerie, ponti, stazioni di servizio, sovrappassi, svincoli a quadrifoglio, massicci riporti di materiale per colmare le disuguaglianze del terreno. Autostrada che si snoda alterando più o meno profondamente gli ecosistemi preesistenti, visibile anche da siti archeologici di rilievo come il tempio e il teatro greco di Segesta, profonda ferita inferta al panorama che gli antichi spettatori delle tragedie avevano come fondale, mentre seguivano lo spettacolo. L’autostrada non la vediamo. Se veniamo da Messina, non abbiamo visto neanche le ciminiere, i tubi, i serbatoi, i fumi della raffineria di Milazzo, e neanche, quasi arrivati a Palermo gli alti, svettanti camini della centrale Enel di Termini Imerese, in riva al mare. Tutto ciò, malgrado la debole resistenza di alcuni, non è stato intercettato dal nostro filtro culturale, anzi l’abbiamo integrato, avendone una percezione positiva, o al più neutra. Non così per un parco eolico.
Lo stesso avviene per i campi fotovoltaici, che non passano il filtro e ci turbano, mentre lo passano i capannoni industriali, sparsi dovunque, le aree industriali, i nuovi centri logistici che occupano ettari. Non vediamo, cioè, lo spaventoso consumo di suolo che si è materializzato sotto i nostri occhi. Secondo l’Ispra nel 2023 i campi fotovoltaici hanno rappresentato solo lo 0,83% di tutto il suolo occupato da cemento, asfalto e altre coperture artificiali.1 Una quota irrilevante. Ma ci accorgiamo solo dei campi fotovoltaici. E inoltre, a conti fatti, tutto il fotovoltaico in campo necessario a garantire all’Italia la condizione emissioni nette zero nel 2050 sarà pari a solo l’8% della Sau (Superficie agricola utile) che è stata abbandonata dal 1980 al 2020, e che attualmente è improduttiva, e allo 0,9% dell’intero territorio nazionale. Avendo già sistemato sui tetti la quota che vi si può sistemare, bene inteso, che da sola non basta. Malgrado questi numeri, si continua a presentare la transizione verso le fonti rinnovabili come qualcosa che minaccia di stravolgere il paesaggio di tutto il territorio italiano.
Chi non ricorda la tragedia del ponte Morandi, a Genova? E tutti abbiamo visto quel mostruoso viadotto che passa sopra parte della città. Ci siamo affrettati a ricostruirlo, col tocco di Renzo Piano per renderlo più digeribile, ma allo stesso tempo la soprintendenza ha bocciato l’installazione di un impianto eolico sulla nuova diga foranea “in quanto eccessivamente impattante in relazione ai valori paesaggistici e storico-paesaggistici tutelati”. Invece la nuova diga foranea non impatta, e il viadotto col ponte Morandi neanche. Il fatto è che i viadotti sulla testa sono ormai parte della nostra cultura, e le dighe foranee pure. Gli aerogeneratori, i campi fotovoltaici no. E ci rifiutiamo di accettarli.
Del bello e dell’utile
Ci sono due ragioni della diversa percezione di elementi ben più impattanti come le autostrade, le superstrade, i viadotti, i tralicci dell’alta tensione, rispetto ai campi eolici e fotovoltaici. Quando cominciarono a costruirsi i primi tralicci, essendo qualcosa di nuovo che si andava a piantare nel paesaggio preesistente, certo apparivano come qualcosa non particolarmente piacevole a vedersi, ma la loro presenza si associava alla possibilità del cambiamento della qualità della vita: portava l’energia elettrica nelle case, negli uffici, nelle fabbriche. Si riconosceva un rapporto di causa-effetto, immediato. Effetto benefico e quindi, anche se non mi piace, me lo faccio piacere, perché me ne viene qualcosa. Analogamente con l’autostrada, la superstrada: posso muovermi più rapidamente, posso viaggiare più facilmente, porta nuove attività economiche, occupazione, benessere. E che importa se è causa di profonde ferite nel territorio, se ciò si accompagna a un immediato percepibile miglioramento della mia qualità della vita? Se mi oppongo al traliccio, all’autostrada, sto peggio, o almeno non miglioro, e poi, soprattutto, tutto ciò è percepito come simbolo di progresso, concetto che ha permeato la cultura come qualcosa di sempre positivo, da inseguire, mai contrastare.
E l’eolico e il fotovoltaico? Eh, no. Per questi le cose non vanno così, non sono associati all’idea di progresso, non ci danno niente di nuovo. L’elettrone prodotto dalla turbina eolica o dal fotovoltaico non è distinguibile da quello prodotto da una centrale termoelettrica, non è migliore, non mi porta nessun vantaggio. L’elettricità prima l’avevo e poi l’avrò uguale. Non cambia la mia qualità della vita. E il cambiamento climatico? I vantaggi futuri? Futuri, appunto, con in più un difetto: se riusciamo a sostituire le fonti fossili con le rinnovabili, non succederà la catastrofe che succederebbe se non lo facessimo, cioè non ci sarà nessun miglioramento rispetto a oggi, non mi accorgerò di niente, perché quel peggio che succederà se non azzero le fonti fossili non lo vedrò se le ho azzerate. Non mi accorgerei del beneficio. “Cioè”, dice chi è orripilato dal campo eolico in cui si imbatte percorrendo l’autostrada, “io dovrei accettare questo orrore e poi non succede niente di cui possa percepire un beneficio? È progresso questo?”.
È l’incapacità umana di agire in anticipo rispetto a pericoli lontani.
Ma perché orrore? Orrore perché la turbina eolica è brutta, è una nota discordante, è fuori scala, è stato detto. Vero, è fuori scala. Ma allora molto più fuori scala sono i grattacieli di Dubai, alcuni dei quali si ergono fino a oltre 400 metri, rispetto alle tende e ai villaggi beduini che c’erano prima, ma centinaia di migliaia di turisti vanno lì a vederli. I grattacieli no, quelli non sono fuori scala. Non sono fuori scala le torri fino a 200 metri di altezza del complesso CityLife a Milano. La torre uffici non è fuori scala, la torre che sostiene il rotore di un aerogeneratore sì: è una questione di percezione, che deriva da una cultura per la quale il grattacielo è espressione del progresso, che si esprime anche nella capacità umana di costruire cattedrali laiche sempre più alte.
E che dire della torre Eiffel? Contrastata all’inizio, considerata una inaccettabile ferita nello skyline di Parigi, assolutamente fuori scala, e oggi icona della città, come a Roma il Colosseo.
Opporsi a un parco eolico in nome della sua bruttezza o del suo essere fuori scala non è accettabile. Non dimentichiamo che Platone fa concludere a Socrate, nel dialogo con il filosofo Ippia, che il bello non è definibile univocamente, in qualsiasi contesto, è piuttosto una tendenza interiore del tutto soggettiva che, oltretutto, può mutare – e di molto – anche nel corso della vita stessa di ogni uomo. A distanza di secoli Voltaire diceva: “Chiedete a un rospo cos’è la bellezza [...]. Vi risponderà che è la sua femmina, coi suoi begli occhioni rotondi...”.
Bisogna anche considerare che opponendosi a un parco eolico – che pur considerando le opere infrastrutturali necessarie per la sua costruzione occupa pochi ettari utilizzabili per coltivare o come pascolo – si contribuisce alla devastazione di migliaia di ettari, nella stessa zona o in altre parti del paese o del mondo, a causa del cambiamento climatico che procede inesorabile se ci si oppone all’uso delle fonti rinnovabili e si continuano ad usare le fossili. Ma sono conseguenze invisibili, non riportabili a effetti immediati e locali di causa-effetto, e quindi non si prendono in considerazione.
Dicendo no all’agrivoltaico per principio perché il paesaggio percepito non sarà più uguale a prima e sarà peggiore (anche se le colture che si mettono sotto i pannelli montati a tre metri d’altezza e opportunamente distanziati in molti casi ne possono trarre beneficio e richiedono meno acqua), si aumenterà la probabilità che da qualche altra parte si finisca per vedere un altro paesaggio non più uguale a prima, perché senza vita in quanto ricoperto dallo strato di melma essiccata lasciata dall’ultima alluvione, o bruciato da un incendio, o devastato da una tromba d’aria, o inaridito dalla siccità. Tutto ciò perché se le fonti rinnovabili non sostituiscono le fossili, il paesaggio che ne deriverà non avrà più nulla in comune con quello attuale, comunque. Sarà il paesaggio dell’Antropocene.
E questo vale anche per chi si oppone alle rinnovabili nelle aree agricole abbandonate: quei paesaggi incontaminati, lontani alla vista e che si vogliono preservare, cambieranno sotto i nostri occhi comunque. Saranno devastati per effetto del cambiamento climatico, tanto più quanto meno impianti eolici e fotovoltaici metteremo.
Si teme che la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici attirerà speculatori di ogni sorta, lestofanti e mafiosi? È un pericolo da non sottovalutare, e probabilmente la mano della mafia e della speculazione ha già operato, ma è una questione che attiene a regole, controlli, polizia e magistratura. Il sistema sanitario, per esempio, è soggetto a identici rischi, ma non per questo merita di essere demolito.
E poi, chi ci assicura dietro all’opposizione per principio alla loro realizzazione, perché devastano il paesaggio, non ci sia l’ombra di un’altra mafia, più potente: quella delle multinazionali del fossile?
Il paesaggio è sempre cambiato
Dobbiamo avere il coraggio di prenderne atto, di farcene una ragione: la transizione energetica, che è parte di quella ecologica, implicherà necessariamente una trasformazione del paesaggio. Così è stato con la transizione dalla caccia-raccolta all’agricoltura, così è stato con la rivoluzione industriale, così non potrà che essere con la transizione energetica.
Il paesaggio è sempre cambiato, come magistralmente ci dimostra Emilio Sereni, perché “è sempre il risultato definitivo e incancellabile di ogni trasformazione, lo sbocco ultimo, incarnato nel territorio, di tutto un mutamento avvenuto anteriormente: il mutamento sociale, il mutamento dei modi di produrre, dei modi di abitare, trascorrere i giorni, guardare al mondo e alla vita [...] il paesaggio si fa specchio del rapporto tra il nuovo e il vecchio, tra ciò che esiste e ciò che si sovrappone”.
È sempre cambiato, tanto che un paesaggista può chiedersi: “è giusto che le (inevitabili) trasformazioni del paesaggio vengano sottoposte a regole? Che si distingua fra trasformazioni ammesse e non ammesse, fra interventi leciti e non leciti? A chi spetta questo compito? Con quale autorità si possono (o si devono) fissare norme, imporre limitazioni, comminare sanzioni?”.
Non si può pretendere che tutto resti com’è quando tutto deve cambiare, quando si deve uscire dal paradigma lineare estrai-produci-usa-getta per entrare in quello dell’economia circolare, quando si deve abbandonare il consumismo e l’agricoltura industriale per abbracciare la sobrietà e l’agroecologia.
Osserva Giuseppe Barbera che i nuovi paesaggi rurali dovranno confrontarsi con le fonti rinnovabili, “ottimizzandone la presenza attraverso una visione agroecologica in grado di mettere in relazione le necessità energetiche, agronomiche, ecologiche, della pianificazione territoriale, con le esigenze culturali e sociali delle popolazioni rurali e dei consumatori”.
E non si può ignorare che l’agroecologia implica un paesaggio agrario diverso da quello attuale, dell’agricoltura industriale, e se non si mette in atto non si riesce a fermare il riscaldamento globale. Ciò perché il cambiamento climatico, effetto del riscaldamento globale, non dipende solo dalla CO2 derivante dalla combustione dei combustibili fossili, ma per ben un quarto dal metano e dal protossido di azoto generato dall’agricoltura industriale, oltre che dalla trasformazione di terreni naturali in terreni produttivi.
Non si può pretendere che tutto resti com’è quando si muove un nuovo passo nel processo di coevoluzione fra uomo e ambiente, e si ripristina l’antica alleanza, l’antica simbiosi coevolutiva, come unica strada da percorrere per allontanare la catastrofe. Dobbiamo costruire un sistema resiliente, intendendo per resilienza quella dei sistemi ecologici, non quella dei sistemi meccanici, a cui in genere si fa erroneamente riferimento. Solitamente si richiama la parola resilienza pensando alla capacità di un sistema di tornare nelle condizioni originarie dopo una forte sollecitazione. Questa è la resilienza meccanica. Quella ecologica è quella dei sistemi complessi, e consiste nella capacità di preservare l’identità e la funzionalità di un sistema anche attraverso sostanziali cambiamenti strutturali. È questa la resilienza di cui dobbiamo avvalerci per mettere in atto la transizione energetica, e si basa sul cambiamento della struttura del sistema energetico e produttivo e sulla diversità delle fonti energetiche usate, in analogia alla diversità dei sistemi ecologici.
Quindi dobbiamo accettare che i nostri paesaggi si evolvano, e diventi normale – culturalmente metabolizzato e percepito come accettabile, anzi positivo – vedere turbine eoliche, campi agrivoltaici e fotovoltaici a terra, come abbiamo imparato a vedere come normali i tralicci dell’alta tensione, i viadotti, le gallerie, le fabbriche con le loro ciminiere. Anzi, dobbiamo imparare a trovare (magari a progettare e costruire) la bellezza di questi interventi sul territorio.
Nel corso della seconda metà del secolo scorso si pose un problema analogo in architettura. Cresceva il numero e la dimensione degli impianti di climatizzazione, di illuminazione, di ventilazione, ed erano corpi estranei, non c’erano mai stati in passato, e si faceva di tutto per nasconderli. Non era un’impresa facile, e non solo comportava dei costi aggiuntivi, a volte ne pregiudicava la funzionalità. Ma ci fu qualcuno che rivoltò il problema, decidendo che invece di nasconderli li si potesse mostrare, anzi esibire, integrandoli esteticamente e funzionalmente nel progetto architettonico. E così, ci ricorda lo storico dell’architettura Reyner Banham, sono nati due capolavori dell’architettura moderna quali il Centre Pompidou di Renzo Piano e Richard Rogers a Parigi – con i suoi condotti colorati – e il Richards Memorial Laboratories di Louis Kahn a Philadelphia – con le sue torri di servizio in mattoni ciechi. Qualcosa di simile bisogna fare con le tecnologie di conversione delle fonti rinnovabili.
Il paesaggio della nuova alleanza
L’homo sapiens per millenni è vissuto in armonia con la natura, che era la sola fonte di tutto ciò di cui aveva bisogno, dal cibo, ai materiali, all’acqua. E non perché fosse migliore di noi, ma perché non aveva scelta. Non disponeva di fonti di energia apparentemente inesauribili né della capacità tecnologica di utilizzarle, e quindi non poteva non adattarsi alle regole della natura, in cui non ci sono fonti di energia né di materia inesauribili, e la pagava duramente quando cercava di ignorare queste regole. Poi, scoperto il modo di estrarre ed utilizzare le fonti fossili, lo stesso homo sapiens si è lasciato prendere dall’hybris e ha creduto di potersi permettere di ribellarsi, di spezzare la simbiosi, la coevoluzione, l’alleanza che c’era stata fino ad allora. Forse troppo tardi ora l’homo sapiens – o almeno qualche esemplare di questa specie – ha capito che non c’è per lui alcuna possibilità di sopravvivenza se non ripristina l’antica alleanza, se non torna a vivere e a svilupparsi in armonia con la natura, cioè accettandone i principi che ne regolano il funzionamento.
Il paesaggio della nuova alleanza dovrà essere caratterizzato dall’abbandono delle energie fossili, dalla scomparsa delle ciminiere delle centrali elettriche, della cementificazione selvaggia, e dall’abbandono dell’agricoltura industriale. I campi saranno coltivati secondo i principi dell’agroecologia, l’ecosistema agricolo dovrà essere ripristinato, e il paesaggio ne risentirà. Disseminati nel territorio, poi, ci saranno campi fotovoltaici e agrivoltaici, opportunamente situati, e non li percepiremo più invasivi di quanto non ci siano apparsi invasivi i tanti bacini artificiali, le reti di canali, le strade, e tutte le opere dell’uomo che sono servite a migliorane la qualità della vita. E alcune vallate ventose, creste di montagne e di colline ospiteranno quei giganti che si sbracciano amichevolmente, e non minacciosamente come credeva Don Chisciotte; giganti che da ferite del paesaggio ne diventeranno icone, e i turisti andranno a visitarli, come già comincia a succedere. Non li percepiremo più estranei, brutti, fuori scala, sapendo che la nostra sopravvivenza, e quella della biosfera di cui siamo parte, dipenderà anche da loro, dal loro lento roteare.
Gli impianti fotovoltaici ed eolici sono opere di pubblica utilità, anzi di pubblica necessità, per la responsabilità che abbiamo nei confronti di chi verrà dopo di noi. Ma attenzione, il fatto che siano opere di pubblica necessità non toglie che prima di tutto venga l’imperativo di preservare la nostra storia, la nostra cultura e l’ambiente. Lì dove ci siano paesaggi di alto valore storico e culturale da difendere, o un ecosistema prezioso, non c’è spazio per parchi eolici o fotovoltaici. Bisogna però evitare gli estremismi, calibrare opportunamente l’aggettivo “alto”, per trovare un equilibrio fra la difesa della attuale percezione di un paesaggio e il danno futuro che può derivare dalla sua conservazione. Occorre trovare un equilibrio fra preservare il passato e preservare il futuro. Futuro che non è nostro, perché – sembra sia un antico detto degli indiani americani –“non ereditiamo la terra dai nostri avi; la prendiamo in prestito dai nostri figli. Nostro è il dovere di restituirgliela”. Vivibile, possiamo aggiungere.
Articolo pubblicato su connettere.org, 10 gennaio 2025
Immagine: Jason Mavrommatis (Unsplash)