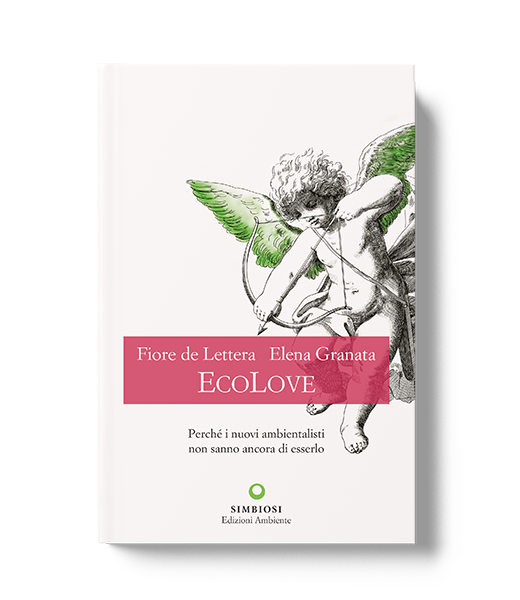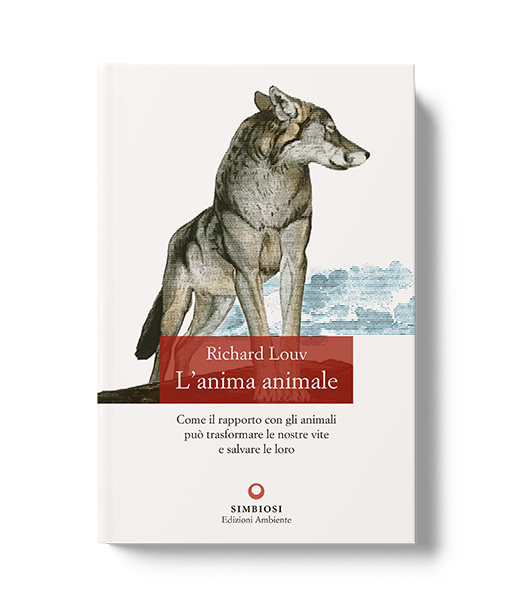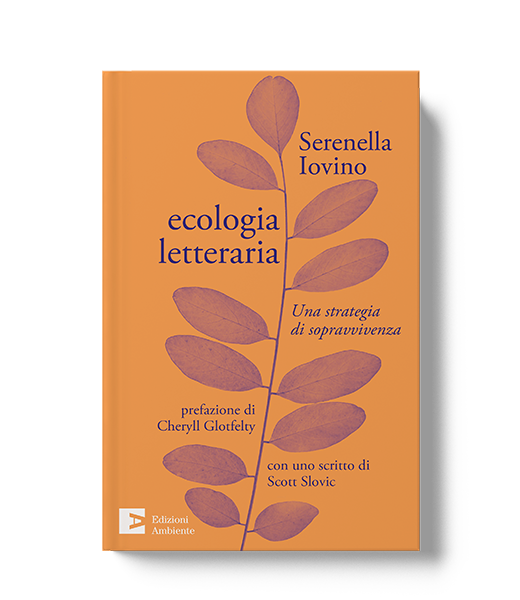Innamorati e senza parole
EcoLove di E. Granata e F. de Lettera
Indagando il fenomeno di innamoramento collettivo per la salvaguardia del pianeta che attraversa artisti, letterati, giovani e meno giovani, ma anche aziende e scienziati, Elena Granata e Fiore de Lettera intraprendono un viaggio intorno al tema ambientale che ci conduce fuori dalla ragione e dalla logica, che ci porta nel mare del sentimento, dell'arte, della comunicazione, dei media, lontani dal solco dell'ambientalismo scientifico e impegnato che conosciamo, osservando nuove forme di creatività, nei singoli e nelle comunità. Perché dati e numeri non bastano a smuovere le persone e a motivarle ad agire. Servono parole per nominare le cose e per esprimere i sentimenti che suscitano, e insieme alle parole servono nuove narrazioni, per raccontare storie diverse da quelle che ci hanno raccontato finora.
Ecco un estratto da EcoLove.
"Ci voleva un grande scrittore per farci spostare il punto di osservazione sulla grande crisi ambientale e per aprirci nuovi spazi di pensiero.
Nel 2016 Amitav Ghosh pubblica il libro La grande cecità e, scostandosi dalla maggior parte della letteratura di evasione, osserva per primo come la crisi ambientale sia anche una crisi del pensiero e della cultura, della capacità collettiva di guardare ai problemi e di trovare le soluzioni più adatte a essi, un'inerzia del pensiero e della volontà. Due anni dopo, l'argomento viene ripreso da David Wallace-Wells, che evidenzia come soffriamo collettivamente di un'incredibile mancanza di immaginazione. Intrappolati dentro visioni consolidate e abitudini del pensiero, siamo vittime di una sorta di torpore che ci impedisce di immaginare un mondo diverso da come lo conosciamo e che i tanti altri 'come' della nostra vita (come abitiamo, come consumiamo, come ci muoviamo) possano essere sostanzialmente differenti. Questo è il punto.
[...]
Se la crisi climatica è una crisi della nostra immaginazione, come facciamo a riappropriarci della nostra capacità di osservare e raccontare ciò che succede, ma anche di immaginare ciò che potrebbe cambiare? Questo tempo di innamoramento universale verso i temi ambientali può innescare percorsi concreti di cambiamento? Può suscitare una nuova immaginazione dei futuri possibili?
[...]
Oggi la questione non è più solo quella di rendere le persone consapevoli dei rischi che corriamo, ma anche di motivarle, spingerle e appassionarle a un cambiamento reale, a partire dalle nostre vite.
La prima cosa che ci colpisce nel dibattito intorno alla questione climatica è l'assoluta povertà di parole che usiamo per restituirlo. Le parole che rimbalzano sui media sono poche e sempre le stesse, in un paradossale vuoto lessicale che impedisce di dire e argomentare con precisione ciò di cui parliamo. Ci muoviamo tra perifrasi, slogan, luoghi comuni, tautologie, locuzioni ripetute e consumate dall'uso.
Siamo tutti innamorati dell'ambiente, avvertiamo la fascinazione nuova per questi temi, ma in fondo non sappiamo bene di che cosa stiamo parlando, e non abbiamo neppure un vocabolario esteso che ci aiuti a esprimere sentimenti, cose, visioni, modi di vivere, volontà. Ci mancano le parole per nominare le cose e per esprimere i sentimenti che suscitano. I linguisti ci insegnano che se una parola non esiste nel lessico di una comunità è perché quella comunià non ha mai interiorizzato l'idea o percepito il sentimento racchiuso in quella parola.
Oltre a essere spia della povertà del pensiero, sappiamo d'altra parte che la povertà lessicale è direttamente proporzionale alla giovinezza dei temi e del comparto culturale. Pensiamo a quanti termini attinti dal mondo economico o dal digitale sono entrati nel lessico (e quindi nel pensiero) comune, e quanti pochi termini ci consentano oggi di esprimere il cambio delle stagioni, gli usi e le funzioni dei suoli, il movimento delle maree, l'intensificarsi delle piogge, le ansie e le sensazioni finora sconosciute per quanto sta accadendo al clima, le nuove forme di resistenza civile.
Robert MacFarlane ha osservato come la nuova edizione dell'Oxford Junior Dictionary non riporti più lemmi come spiga, ragno, cenere, faggio, giacinto, ranuncolo, amento, castagna selvatica, primula, cinghietto, dente di leone, felce, nocciolo, erica, airone, edera, martin pescatore, allodola, vischio, nettare, tritone, lontra, pascolo e salice piangente. Le parole introdotte nella nuova edizione sono: allegato, grafico a blocchi, blog, banda larga, elenchi puntati, celebri, chatroom, comitato, taglia-e-incolla, lettore MP3 e segreteria telefonica [MacFarlane R., Landmarks, Hamish Hamilton, Londra 2015] .
Come esprimere a parole gradazioni e sfumature relative alla gravità e alla portata del cambiamento climatico? Come descrivere le varie dimensioni della crisi ecologica e umanitaria che tutti affrontiamo? Come spiegare dal punto di vista emotivo e psicologico l'influenza che certi lemmi hanno oggi sul nostro cervello? Ci vorrà un nuovo dizionario per descrivere il modo in cui vivremo e abiteremo i luoghi nel futuro.
È quello che hanno cominciato a sognare, progettare e poi redigere il sociologo di Yale Matthew Schneider-Mayerson e l'esperto di letteratura fantascientifica Brent Ryan Bellamy, della Trent University dell'Ontario, coeditori di An Ecotopian Lexicon (2019): un'antologia sui generis che elenca origine e usi possibili di trenta neologismi scelti da altrettanti esperti in discipline diverse e presi in prestito da culture e sottoculture eterogenee, dalla fantascienza alla poesia.
I due curatori sono assolutamente convinti del potere che le parole hanno di influenzare la percezione del mondo e il nostro pensiero; in fondo la stessa voce 'ecologia', tanto evocativa ai giorni nostri, è stata inventata solo nel 1873 da Ernst Haeckel, biologo, zoologo, filosofo e artista tedesco. Oppure pensiamo alla parola 'biodiversità', che diventa materia di studi a partire dal 1968 grazie all'ecologo Raymond Dasmann e qualche anno dopo al biologo Thomas Lovejoy, ma che possiamo ritenere realmente inventata nel 1988 dal biologo Edward O. Wilson che le dedicherà studi e passione per l'intera vita. A lui dobbiamo la coniazione di biodiversity e la comprensione profonda del valore della diversità biologica come tratto fondamentale di tutto il pianeta e come condizione fondamentale per la sua esistenza e sopravvivenza.
Le parole aprono mondi, spalancano immaginari, generano discipline e campi di studio, alimentano arte e letteratura.
Secondo Matthew Schneider-Mayerson e Brent Ryan Bellamy abbiamo bisogno di un nuovo vocabolario che metta insieme parole prese in prestito dalle varie culture e lingue a nostra disposizione, che ci consenta di modellare con più efficacia le nostre conversazioni e, naturalmente, di comprendere meglio i termini del problema.
[...]
La cultura ambientalista ha collezionato slogan e motti anche fortunati ma spesso poco capaci di suggerire immagini. Negli ultimi due decenni, uno dei gridi di battaglia più popolari di attivisti e studiosi in Occidente è stato 'there's no Planet B', cosi` come il suo contrario 'another world is possible'. Quest'ultimo, nato più di vent'anni fa in seno alla protesta anti-capitalista e no-global e arricchitosi con gli anni della valenza ecologista, è stato cantato in migliaia di manifestazioni di protesta, scritto e rimasticato in tutte le lingue del mondo.
Il solo Google riporta 3.220.000.000 di volte la frase 'un altro mondo è possibile', ma che cosa significa?
È la risposta consapevole alla rassegnazione che non ci siano alternative. Descrive bene l'atteggiamento politico di chi rifiuta un destino già scritto ma resta privo di un contenuto descrittivo e propositivo.
In questo momento di crisi climatica, la sfida più ovvia che dobbiamo affrontare è politica, ma abbiamo sul tavolo anche una monumentale sfida culturale: coltivare, costruire e propagare narrazioni che possano ispirarci durante questa benedetta transizione.
Non esiste ancora un grande cloud di significati e significanti adatto alla nuova era ecologica e dobbiamo svilupparlo proprio grazie all'immaginazione. Per farlo stiamo attingendo, oggi, alle tradizioni indigene, alle lingue popolari, ma anche al mondo dei fumetti, dei romanzi distopici e alla fantascienza.
Immaginare un futuro diverso inizia, per esempio, da una rinnovata conoscenza del cibo, come suggerisce la parola cibopathic, neologismo proposto da Daniel Worden, studioso di scienze politiche al Rochester Institute of Technology, parola presa in prestito dalla serie di fumetti Chew, scritta da John Layman e disegnata da Rob Guillory (uscita per la prima volta nel 2009 e conclusa nel 2016 dopo 60 numeri).
Proviamo a risalire il percorso del senso di questa nuova parola. Chew si svolge in un mondo emerso da una pandemia di influenza aviaria che ha ucciso milioni di persone. I polli e altri prodotti a base di pollame sono stati messi al bando e la Food and Drug Administration degli Stati Uniti è diventata una delle principali forze di polizia.
Il protagonista della serie, Tony Chu, è un cibopata, ovvero un uomo che ha la capacità di cogliere attraverso i sensi la storia di quello che mangia. E così attraverso il suo gusto veniamo immersi nei complessi meandri della trasformazione dei cibi e nella catena dell'industria alimentare che manipola la natura per restituirla alterata e seduttiva per i palati di tutto il mondo.
Il fumetto ha come protagonista quell'industria di settore così attenta a spiegarci come il cibo sia stato coltivato, raccolto, elaborato, trasportato con metodi naturali, che fa leva sulle consuete etichette ammiccanti (sintagmi come 'biologico', 'allevato a terra', 'senza Ogm', 'di provenienza locale') ma che prescinde in molti casi dalla reale storia dei cibi.
Queste categorie sono spesso fuorvianti nelle loro connotazioni, suggerendo un'origine locale per prodotti alimentari industriali o, per paradosso, facendo apparire i prodotti delle piccole aziende agricole (davvero locali) meno sostenibili agli occhi del pubblico solo perché sprovvisti di quel marchio di qualità o di quella certificazione di cibo biologico. Lungi dal disconoscere il ruolo di tali marchi e disciplinari (come Dop o Igp in Italia), nella tutela e nella valorizzazione dei prodotti tipici locali è però un fatto, ormai ampiamente dibattuto, che le spese eccessive per l'ottenimento degli stessi marchi penalizzino inesorabilmente i produttori più piccoli. Da questo cul-de-sac burocratico-alimentare bisognerebbe davvero uscire al più presto.
Il fatto che questi sintagmi siano diventati comuni sia nella grande distribuzione sia nel mercato dell'agricoltura locale rende evidente come gli attuali movimenti alimentari siano entrambi legati, pur nella loro differenza, all'ambientalismo contemporaneo. L'abilità del cibopata è quella di saper distinguere, di leggere con i sensi e oltre le etichette, riuscendo a smascherare il sofisticato tentativo di confondere il consumatore.
La svedese Sofia Ahlberg dell'Università di Uppsala introduce la parola fotminne, derivata dal greco, che significa 'la memoria del piede', per indicare la relazione stretta tra il nostro corpo e il terreno che calpestiamo. Questo termine allude all'esperienza profonda del camminare e del ricordare, del muoverci dentro luoghi che ci sono noti e che trattengono ricordi e pensieri legati alla nostra vita. Senza una parola per dirlo perdiamo quel dettaglio della nostra esperienza di abitanti che pure tutti facciamo.
Un altro termine proposto dal Lexicon è iperempatia, che cerca di raccontare come l'Antropocene non riguardi solo una trasformazione esteriore - della chimica oceanica, delle coste o degli habitat - ma anche interiore, riconducibile alla dimensione più intima dell'esperienza umana. Cosa e come pensiamo alle nostre relazioni con i diversi ambienti in cui ci troviamo, con le risorse che abbiamo a disposizione? Possiamo imparare a ragionare o a percepire in modo diverso? A quali scenari e possibilità dovremmo prepararci e cosa osare immaginare? Quali attitudini emotive e sentimentali potrebbero aiutarci a sopravvivere?
L'iperempatia è la capacità di provare dolore o sofferenza anche per situazioni che non ci coinvolgono direttamente, per esempio il disagio per la sofferenza degli animali che può provare anche chi è carnivoro. È un orientamento emozionale che, con il tempo, può innescare una reazione decisiva di fronte al perpetrarsi dell'ingiustizia ambientale e climatica. L'iperempatia rappresenta una forma trasformativa di sentimento che sperimentiamo quando recepiamo il dolore degli altri; ci consente di vivere nella violenza dell'Antropocene senza diventare distaccati o compiacenti."
Tratto da F. de Lettera, E. Granata, EcoLove, Edizioni Ambiente 2022
Immagine: Chandan Chaurasia (Unsplash)