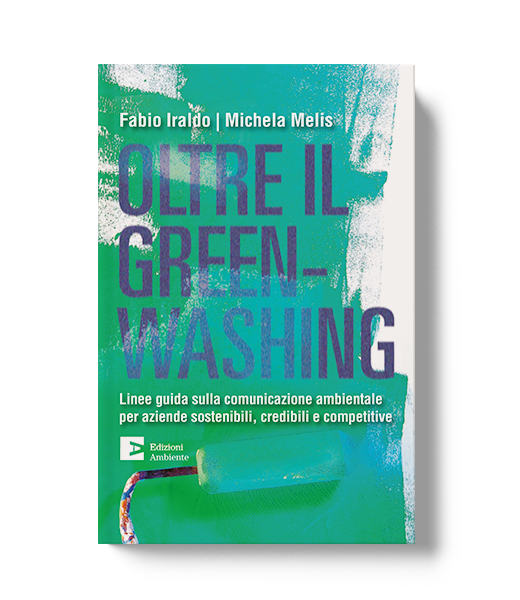L’Europa lava più verde?
Intervista a Fabio Iraldo
La sola notizia che la Commissione europea potesse ritirare la proposta di Direttiva sui Green Claims ha provocato un momento di vero disorientamento e una forte reazione. Agire su quel piano sarebbe un colpo decisamente più vistoso di altri all’idea che si voglia veramente realizzare un green deal europeo. Proprio per l’oggetto di quella direttiva – la difesa del consumatore da un lato e delle imprese che “green" lo sono davvero dall'altro – l’impatto sulla credibilità delle strategie green della Commissione von der Leyen-bis sarebbe stato maggiore di ogni tentennamento o ripensamento su obiettivi di contenimento delle emissioni, pesticidi, phase-out del diesel ecc. Una resa di fronte a un fenomeno fin troppo presente, che lucra sulla crescente attenzione riguardo alle conseguenze delle scelte di acquisto e di consumo.
Quella del presunto dietro-front della Commissione europea rimane una vicenda controversa di cui parliamo con Fabio Iraldo, professore ordinario di management presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e autore con Michela Melis di Oltre il Greenwashing – Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive.
Oltre il Greenwashing
Linee guida sulla comunicazione ambientale per aziende sostenibili, credibili e competitive
Fabio Iraldo, Michela MelisQuale è il contesto che ha portato a formulare questa ipotesi? Chi sono stati i protagonisti su un versante e sull’altro? Quali le motivazioni reali?
Il percorso di ideazione e di sviluppo della proposta di Direttiva Green Claims è stato faticoso e tormentato fin dall’inizio. Non è sorprendente per chi segue questo percorso dai suoi primi passi osservare oggi le dinamiche esplicitamente conflittuali in cui è sfociato, perché queste hanno sempre caratterizzato il contesto in cui è maturata la proposta, anche se erano circoscritte ai tavoli di lavoro ed erano edulcorate dalla diplomazia. I motivi per cui è esploso il conflitto sono noti: vi sono dei punti della proposta che hanno sempre generato preoccupazioni, soprattutto sul versante industriale e produttivo. Va ricordato che le cause della discordia sono mutate nel tempo: i primi draft ufficiosi della proposta erano molto più orientati a valorizzare, per esempio, il ruolo forte dell’Environmental Footprint, il metodo che la stessa Commissione europea aveva sviluppato per garantire fondamenta scientifiche alle valutazioni e alla comunicazione dell’impatto ambientale delle aziende e dei loro prodotti, soprattutto quando indirizzate al mercato. Un primo fronte di oppositori era già riuscito a indebolire molto il ruolo dell’impronta ambientale, che nell’ultima versione presentata come input iniziale al Trilogo era già stata di fatto ridimensionata a “una fra le molte” metodologie che possono essere utilizzate per corroborare i green claims. Questo compromesso era stato raggiunto con uno sforzo dalle parti coinvolte, che sul fronte degli oppositori alla EF erano soprattutto le associazioni di categoria dei settori della produzione agricola e le associazioni industriali delle piccole e medie imprese (attraverso l’azione di alcuni loro settori rappresentativi). Il punto che invece ha portato alla recente rottura è legato principalmente alla verifica e validazione di parte terza (da parte di un certificatore indipendente) dei green claims, preliminare al loro utilizzo per fini comunicazionali e pubblicitari, che la proposta di Direttiva prevedeva per le aziende, con la sola eccezione delle piccolissime imprese. Questo requisito ha rappresentato il casus belli, colto da una serie di attori che tuttavia avevano sempre covato un rilevante scetticismo di fondo e una non velata opposizione all’idea stessa di una Direttiva che andasse a regolare un’attività per definizione creativa e libera da condizionamenti e vincoli, come il marketing e la comunicazione. A ispirare la contestazione sono state, quindi, le associazioni di categoria delle imprese, che hanno “armato” il braccio di alcuni partiti politici presenti nel Parlamento europeo (soprattutto il PPE) e alcuni Paesi membri dell’Unione. Fra questi ultimi, il governo Italiano si è schierato in prima linea, sottraendo il consenso alla proposta, una volta informato delle lettere di contestazione inviate dai partiti politici appena citate. A queste posizioni ufficiali, si sono poi unite molte voci dell’associazionismo industriale, ma non delle singole imprese. Anzi, alcune aziende multinazionali, che dovrebbero essere i soggetti più colpiti dalla Direttiva, essendo i maggiori investitori in campagne pubblicitarie, hanno espresso disappunto per una Direttiva che invece avrebbero apprezzato in quanto in grado di portare ordine in un contesto deregolamentato e “selvaggio”. Sono stato fatti tentativi di ricomporre il conflitto, sondando il terreno per un’estensione della esenzione dell’obbligo di certificazione preventiva dei claim per un numero di aziende superiore (aumentando le dimensioni delle aziende esentate), ma questi sono risultati infruttuosi. A quel punto la Commissione, forte anche del supporto espresso sui media da ong, associazioni ambientaliste e di consumatori e molti osservatori e tecnici (come per esempio alcuni accademici), ha minacciato il ritiro della proposta e ha annullato quella che avrebbe dovuto essere l’ultimo appuntamento del Trilogo, rinviandolo a data da destinarsi.
Quella del ritiro era prospettiva reale o un bluff? Ritirare una proposta di direttiva mentre questa è in discussione è qualcosa che può realmente avvenire?
Sì, certamente la Commissione ha il potere e la possibilità di ritirare le proposta, anche quelle già entrate e perfino in fase avanzata del Trilogo, anche se questa è una prassi molto inusuale poiché scopre il fianco a molte critiche. Prima fra tutte, soprattutto al punto in cui era la Green Claims, quella di aver sprecato le risorse economiche dei cittadini comunitari e il tempo dei delegati ai vari livelli istituzionali e associativi. Tuttavia, nel caso specifico si è chiaramente trattato di una mossa tattica in una negoziazione che si era irrigidita e che non offriva molte altre vie d’uscita, se non quella di andare a uno scontro frontale dall’esito incerto.
L’Italia, come sulla legge per il ripristino della natura e molti altri provvedimenti sull’ambiente è sul fronte dei contrari. Abbiamo un sistema produttivo in cui piccole imprese sono la grande maggioranza. Assolvere alle prescrizioni della Direttiva Green Claims può essere così oneroso tanto da risultare un handicap per la piccola impresa? O effettivamente questa è configurata sulle caratteristiche di altri sistemi produttivi?
L’impianto complessivo della Direttiva, incardinato sull’esigenza che le aziende si basino su evidenze scientifiche per sostanziare i propri claim ambientali nelle pubblicità, non aveva e non ha le implicazioni significative che molti hanno dipinto. Anzi, molte aziende di piccole dimensioni in Italia stanno già lavorando da tempo per rendere credibili e affidabili le proprie asserzioni ambientali, consapevoli che questo sia un elemento (prima ancora che eticamente necessario e da garantire a fronte del rischio di una sanzione del Garante della Pubblicità), assolutamente strategico per riuscire a competere sul mercato, catturando l’attenzione dei consumatori green più esigenti, rispondendo alle loro sempre più sofisticate esigenze di robustezza e credibilità, fornire informazioni e dati in grado di conquistare la loro fiducia e allontanare il sospetto di greenwashing. Il requisito specifico della certificazione di parte terza, invece, era ed è effettivamente un potenziale aggravio dei costi per le imprese, soprattutto per quelle di minori dimensioni. Ma una estensione delle esenzioni previste sarebbe stata in grado di prevenire il rischio di gravare sui costi e quindi sulla competitività delle imprese di minori dimensioni.
Come immagini che possa svilupparsi nei prossimi mesi la discussione sulla Direttiva?
Ci sono due scenari possibili. Il primo è che in modo informale continuino i contatti tra gli Stati Membri e tra i partiti politici e questo porti a un compromesso sui punti critici, primo fra tutti quello della certificazione e si vada così alla conclusione positiva del Trilogo di una versione ulteriormente edulcorata. Il secondo è che la Commissione riveda l’impianto complessivo della proposta, per esempio integrandola in un Omnibus Green (gemello di quello che ha leggermente riformato la disciplina della CSRD, CSDDD e Tassonomia) oppure emendando la Direttiva Empowering Consumer 825/2024 già in vigore, mantenendo alcune colonne portanti della proposta Green Claims, quali per esempio l’evidenza scientifica a supporto dei claim e le “regole” di elaborazione delle asserzioni dell’attuale articolo 3, ma recuperandoli in atti normativi “ex novo” o modificati opportunamente.
Scenario in evoluzione dunque. Rimane il fatto che attualmente per il consumatore non è per nulla facile orientarsi tra claim, loghi, riferimenti a certificazioni che attesterebbero una qualche forma – tra le tante possibili – di attenzione agli impatti ambientali (per non parlare di quelli sociali) da parte delle aziende. Direttiva o meno, per ogni soggetto che non voglia correre il rischio di produrre comunicazione fuorviante, imprecisa o semplicemente di difficile interpretazione per l’utente cui si rivolge, Oltre il greenwashing è un manuale accurato e perfettamente attuale. Per chi ha intenzioni diverse, un libro inutile.
Immagine: Artem Beliaikin (Unsplash)