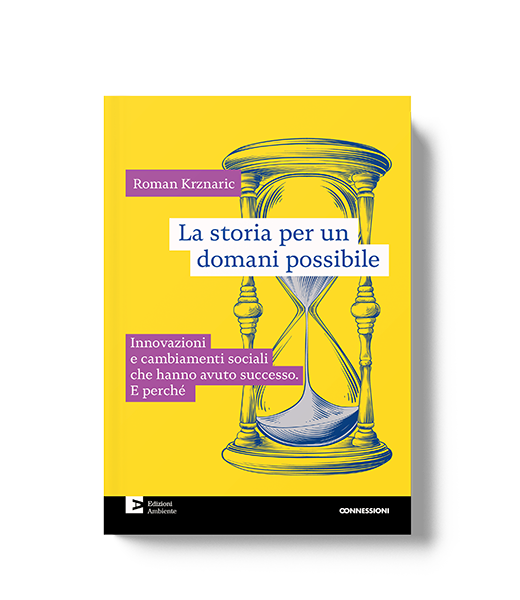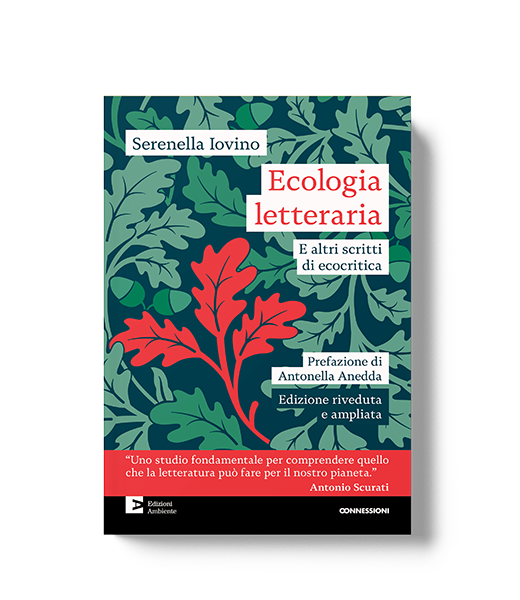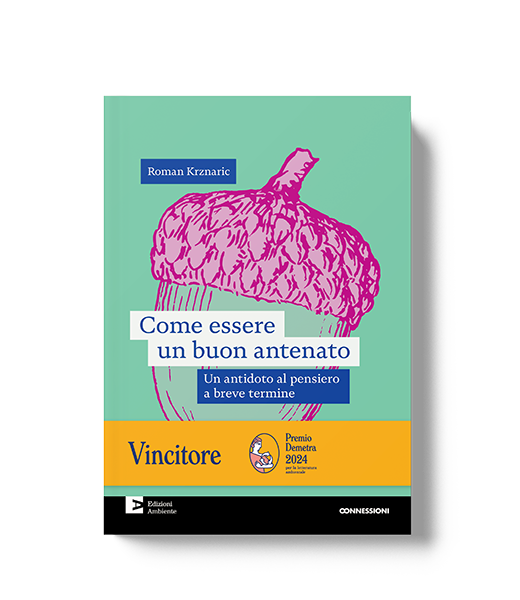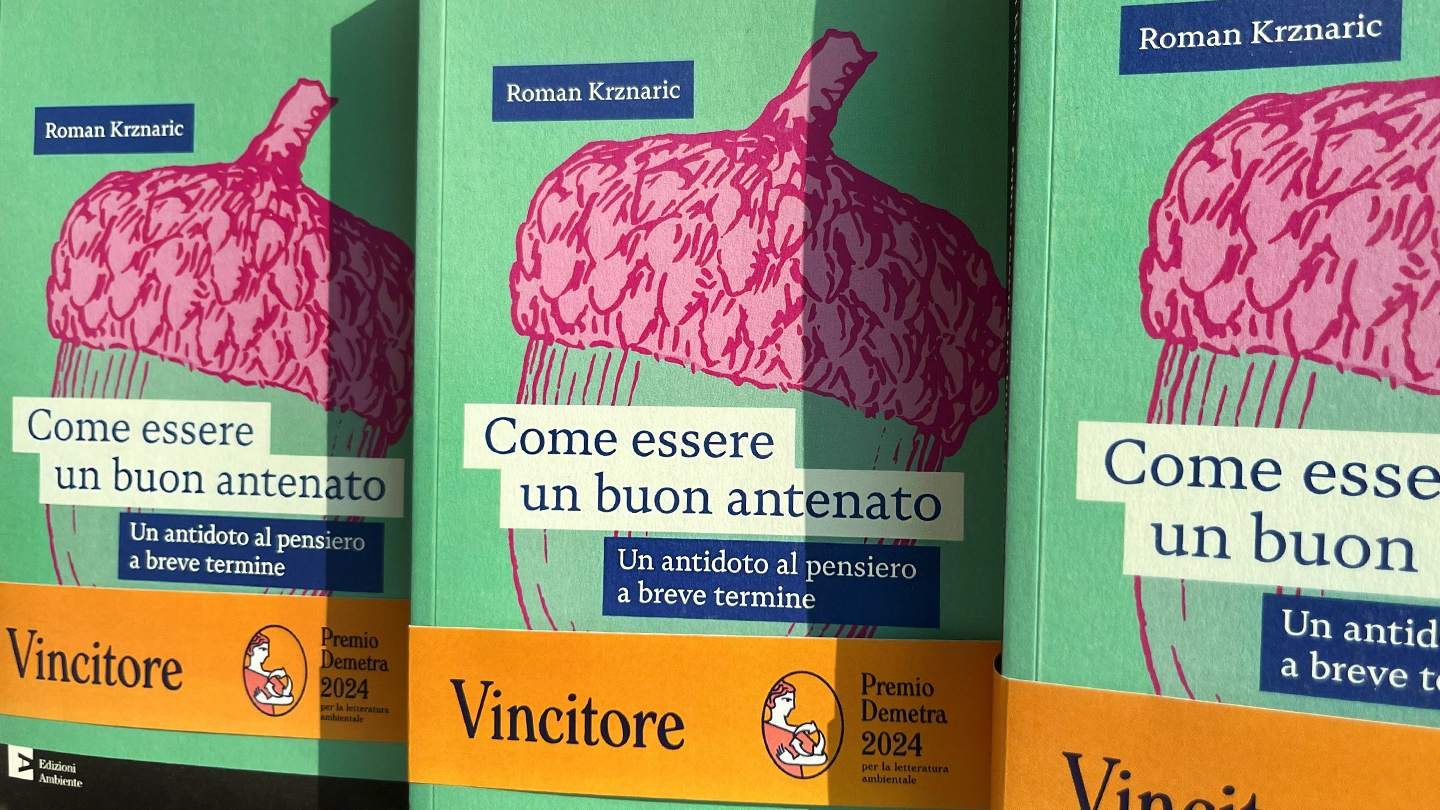Ispirazioni dal passato per il futuro dell’umanità
Intervista a Roman Krznaric
Per Roman Krznaric, filosofo sociale, autore bestseller e senior researcher presso il Centre for Eudaimonia and Human Flourishing dell’Università di Oxford, l’umanità è attualmente su un percorso di autodistruzione ecologica. Ma c’è speranza: la storia racconta che più volte siamo riusciti ad agire in accordo, spesso contro ogni previsione, per superare crisi e sfide. Nel suo ultimo libro, La storia per un domani possibile, ci sono moltissimi spunti e riflessioni su come la conoscenza del passato possa aiutarci a costruire un futuro migliore per l’umanità affrontando le sfide globali di oggi: dalla scarsità di acqua all’aumento delle disuguaglianze, dai rischi dell’ingegneria genetica e dell’intelligenza artificiale fino all’iperconsumismo.
Il passato non va considerato solo come un monito per evitare gli errori, ma come un laboratorio vivo di soluzioni già sperimentate, da riscoprire e adattare alle sfide del presente. Krznaric, dopo il successo di Come essere un buon antenato, prosegue la sua riflessione sul valore del pensiero a lungo termine e del pensiero storico per costruire un futuro più equo, sostenibile e vivibile.
Vi proponiamo un’intervista al filosofo trasmessa da Talk Radio Europe a cura del conduttore Giles Brown.
La storia per un domani possibile
Innovazioni e cambiamenti sociali che hanno avuto successo. E perché
Roman KrznaricParlaci un po’ del tuo ultimo libro.
“Il libro si chiede cosa possiamo imparare dagli ultimi mille anni di storia per affrontare dieci grandi crisi globali: il cambiamento climatico, i rischi dell’intelligenza artificiale, le minacce alla democrazia, le migrazioni e così via. Nessuno può essere esperto di tutti questi temi, ma la storia può offrirci strumenti preziosi per capirli.”
Io sono un appassionato di storia e quando mi chiedono perché mi piace tanto rispondo perché ci insegna tutto! La storia non è lettera morta, scritta dai vincitori: è viva, respira, ci parla del presente e ci mostra come affrontare le sfide di oggi.
“Hai perfettamente ragione. Se torniamo all’Antica Grecia, le persone si preoccupavano della vita e della morte, dell’amore e dell’amicizia proprio come noi. Siamo le stesse persone di allora. Sono cambiate le istituzioni, ma non l’essenza umana. E possiamo ancora imparare a connetterci tra noi, a conversare, a tessere relazioni: è questo che tiene insieme una società.”
Me li immagino i Greci che si lamentano dei “Cartaginesi che arrivano su barche piccole da Tunisi”...
“In un certo senso sì! L’immigrazione è un tema acceso ovunque: in Italia, Spagna, Germania, nel Regno Unito. Eppure, tra XI e XII secolo, nel sud della Spagna, il regno islamico di al-Andalus era conosciuto per la tolleranza tra musulmani, cristiani ed ebrei. Gli storici tendono a dire che uno dei motivi per cui le diverse comunità andavano ragionevolmente d’accordo era il fatto che vivevano a contatto nelle città. Non che fosse perfetto, ma dimostra che convivenza e collaborazione sono possibili. La storia non offre formule rigide, ma libera l’immaginazione: ci mostra che altri mondi sono possibili. Le città, appunto, sono state straordinarie ‘tecnologie sociali’ per unire le persone. Certo, non sono paradisi, ma offrono spazi dove incontrarsi, conoscersi, imparare l’empatia. Dopo aver lasciato l’università, ho lavorato a un progetto chiamato Oxford Muse, creato per far dialogare sconosciuti tra loro. Organizzavamo ‘cene-conversazione’, dove persone di età, classi e background diversi si sedevano a tavola insieme per parlare di argomenti proposti nel Menù. Esperimenti simili funzionano anche online: in Germania, il progetto Deutschland Spricht metteva in contatto persone con opinioni politiche opposte per dialogare su temi divisivi come l’immigrazione o il clima. Bastano poche ore di conversazione autentica per ridurre i pregiudizi.”
Eppure oggi, pessimismo e radicalismo vendono. Gli algoritmi e i media preferiscono i toni accesi: è più facile diffondere rabbia che comprensione. A volte le notizie dipingono un mondo di persone arrabbiate, bandiere, muri, diffidenza. Quell’amplificazione mediatica ha poi un effetto reale, no?
“Assolutamente. Il modo in cui funzionano gli algoritmi è esattamente quello che dici, favoriscono i contenuti tossici, ovvero le notizie negative rispetto a quelle positive per indurre le persone ad ascoltare o guardare i notiziari, che non fanno altro che rinforzare ciò che già pensano. E così ci polarizzano sempre di più, diventiamo una società sempre più divisa. Ma di fronte alle sfide reali che ci attendono – energia, clima, democrazia – abbiamo bisogno gli uni degli altri più che mai.”
Guardando alla storia, abbiamo visto imperi crollare, ma anche piccole società che hanno resistito. Esiste una moralità comune, una solidarietà di fondo…
“Sì, e quella solidarietà è letteralmente dentro di noi. Fa parte del nostro Dna. L’empatia è una capacità biologica, un istinto naturale non solo culturale. È qualcosa che attraversa tutta la storia umana.”
Parli spesso di lezioni storiche pratiche. Puoi farci un esempio concreto?
“Certo. Pensa al Giappone del XVIII secolo, alla città di Edo, oggi Tokyo. All’epoca era una metropoli con oltre un milione di abitanti, più grande di Londra o Parigi, e funzionava secondo principi che oggi definiremmo di economia circolare.
Quasi tutto veniva riutilizzato: un kimono logoro diventava pigiama, poi pannolino, poi straccio, e infine combustibile. Persino i rifiuti umani venivano raccolti e venduti come fertilizzante agricolo.
Era una società feudale e patriarcale, certo, ma rappresenta il primo grande esempio storico di civiltà ecologica a basse emissioni e basso spreco. Ci dimostra che un’economia sostenibile è possibile su larga scala.
E non dobbiamo andare così lontano per trovare esempi simili: i nostri nonni non sprecavano nulla. Vivevano con una sostenibilità istintiva. Dobbiamo solo riaccendere l’immaginazione e ricordarci che un altro modo di vivere è possibile. In un certo senso, è proprio questo il tema centrale del mio libro: guardatevi intorno, guardate il mondo. Non deve per forza essere così. Possiamo fare di meglio. Possiamo fare molto meglio di quanto stiamo facendo ora.”
Qual è quindi il messaggio che vuoi lasciare ai lettori?
“Che serve anche un po’ di ‘disruption’, di scossa, per cambiare davvero le cose. I grandi cambiamenti storici non nascono mai dal consenso, ma da chi osa mettere in discussione il sistema. In Spagna, per esempio, gli Indignados e poi Podemos sono nati così. Non perfetti, ma necessari.
La verità è che la nostra inazione farà infuriare le generazioni future più di qualsiasi errore. Essere ‘buoni antenati’ significa agire ora, per loro. E se davvero vogliamo un futuro migliore, dobbiamo iniziare includendo anche chi quel futuro lo abiterà.”
Immagine: credits Kate Raworth
Intervista radiofonica, 1 novembre 2025, Talk Radio Europe