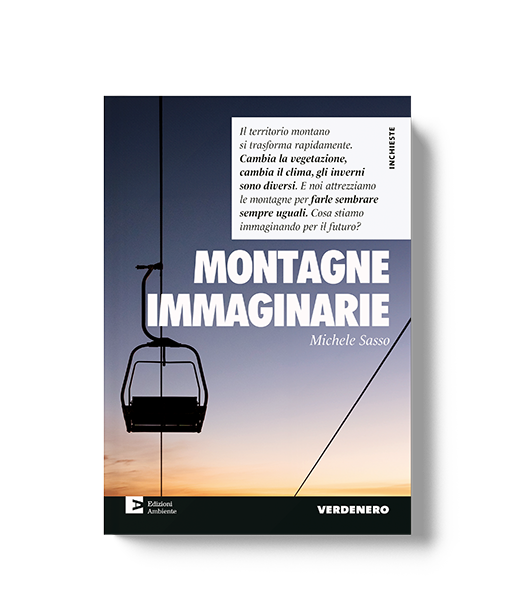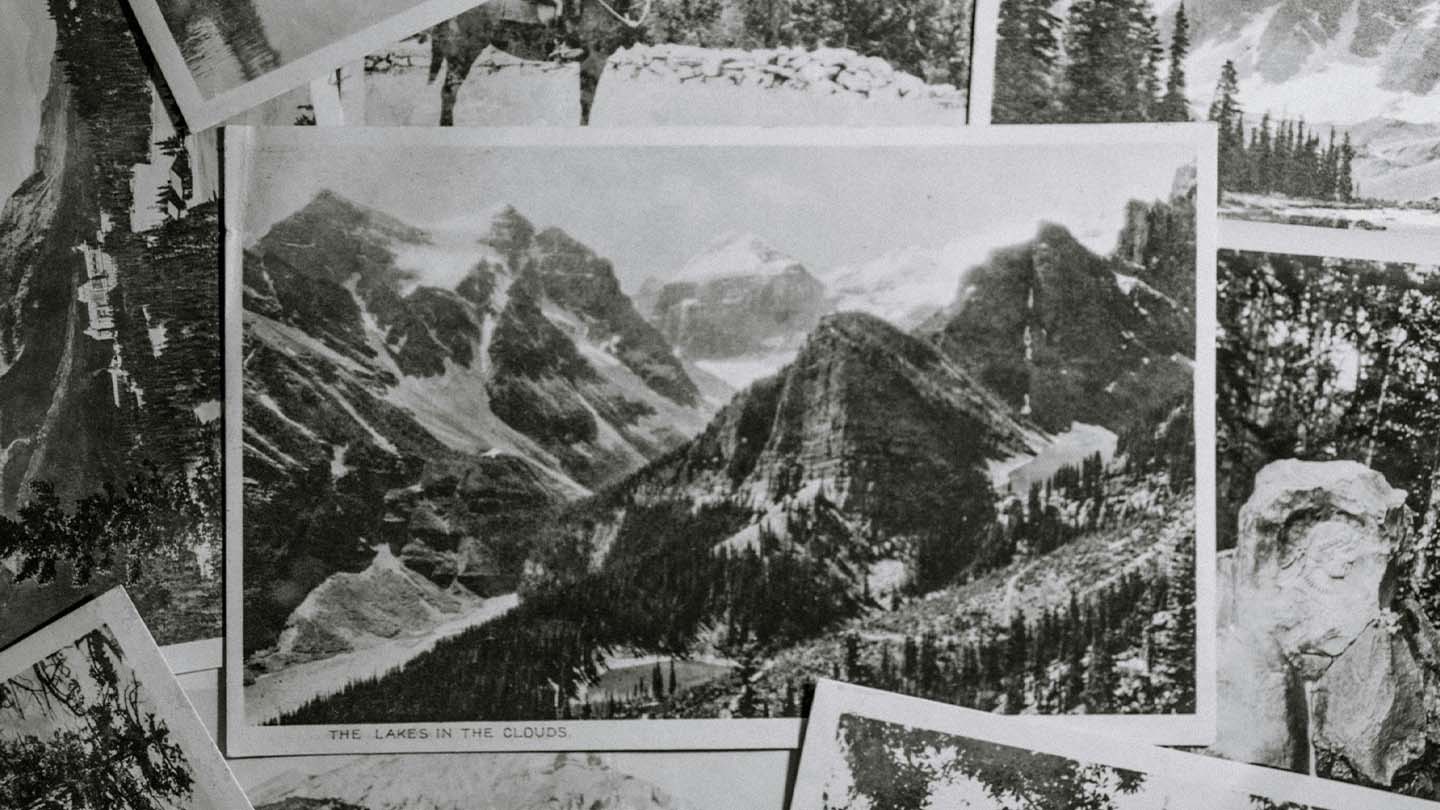Montagne immaginarie e verissime
Come la “restanza” può riportare in vita i luoghi
In Italia, un’intera generazione è cresciuta con l’idea che per realizzarsi bisogna andarsene. Dalla provincia, dai paesi, dalle montagne. Dai luoghi che, in apparenza, risultano privi di prospettive, di stimoli, di possibilità. Territori svuotati da sogni e aspettative, luoghi in cui un futuro sembra lontano se non addirittura impossibile.
Un sentimento collettivo che ha abbracciato molte aree del nostro Paese, prime fra tutte le nostre montagne. Le aree interne e le aree montane, progressivamente sempre più vittima di spopolamento, abbandono.
Parliamo della cosiddetta “montagna di mezzo”, non quella “da cartolina” e “immaginaria”, star inconsapevole dei feed di Instagram e TikTok, di narrazioni artefatte, meta prediletta dei cosiddetti “merenderos”. No, stiamo parlando della montagna che oscilla tra i 600 e i 2.000 metri. Quella che non sfoggia rocce da vertigini, ma modelli di esistenza e di sviluppo alternativi, dettati da ritmi lenti ed esigenze diverse.
“La montagna minore, incastrata tra la voglia di scappare per avere tutto vicino (secondo il modello delle città con i servizi nel raggio di 15 minuti), e chi invece in controtendenza ci arriva per provare”, scrive Michele Sasso in Montagne immaginarie, inchiesta ambientale che esplora, fra le altre cose, il concetto di “restanza” italiana e di nuovi stili di vita per vivificare i territori più fragili.
Ma che cosa è la “restanza”?
La risposta arriva dall’antropologo Vito Teti, intervistato da Sasso nel suo libro: “Restanza è un fenomeno del presente che riguarda la necessità, il desiderio, la volontà di generare un nuovo senso dei luoghi. È questo un tempo segnato dalle migrazioni, ma è anche il tempo, più silenzioso, di chi ‘resta’ nel suo luogo di origine e lo vive, lo cammina, lo interpreta, in una vertigine continua di cambiamenti. La pandemia, l’emergenza climatica, le grandi migrazioni sembra stiano modificando il nostro rapporto con il corpo, con lo spazio, con la morte, con gli altri, e pongono l’esigenza di immaginare nuove comunità, impongono a chi parte e a chi resta nuove pratiche dell’abitare.”
Sono oggi molte le narrazioni spesso retoriche e senza profondità – scrive Michele Sasso – che idealizzano la vita nei piccoli paesi, rimuovendone, insieme alla durezza, le pratiche di memoria e di speranza di chi ha voluto o ha dovuto rimanere. La “restanza” non riguarda soltanto i piccoli paesi, anche le città, le metropoli, le periferie.
“Il problema del restare non è separabile da partire e tornare e tocca le metropoli e le province” spiega l’antropologo Teti. “Abbraccia un concetto più ampio di cercare un luogo e renderlo vivibile. Non credo a certe posizioni che insistono sulla bellezza di restare in più posti. Qualcuno scambia la propria mobilità con quella dei migranti. Questo elogio del viaggiare dipende da chi viaggia e per chi viaggia. In questo mondo così confuso, occorre porre il problema del restare e il problema dell’abitare. Il destino contrapposto alla necessità.”
Nel suo libro, Sasso ci porta in viaggio tra queste aree interne per raccontare chi ha scelto di restare. O meglio, chi ha scelto la restanza. Un termine che diventa una chiave di lettura potente. Perché scegliere di restare oggi in luoghi che si svuotano a favore delle metropoli è tutto tranne che immobilismo.
La restanza non è inerzia. Non è pigrizia. Non è paura di mettersi in gioco. È, come la raccontano Teti e Sasso, una scelta consapevole. Un atto di cura verso il territorio, una forma di resistenza quotidiana, una presa di posizione politica. Restare vuol dire prendersi la responsabilità di trasformare un luogo, invece che abbandonarlo.
Sasso ha percorso l’Italia interna da nord a sud – quella invisibile ai radar dell’overtourism e fuori dagli itinerari più gettonati – per raccogliere storie di persone che credono ancora nei piccoli borghi, nelle montagne fragili, nelle comunità che resistono alla logica del profitto. E lo fa con lo sguardo lucido del reporter e la sensibilità di chi quei luoghi li ascolta, più che raccontarli.
Ci sono le valli dell’Appennino, i borghi dimenticati dell’entroterra lucano, i crinali abruzzesi. Incontri con contadini visionari, sindaci ostinati, attivisti che piantano semi invece di scappare. E poi cooperative agricole, rifugi riaperti, scuole che tornano a pulsare in mezzo al niente.
Sasso dà voce a una geografia emotiva fatta di passione e contraddizioni, dove non si nasconde la fatica del restare. Perché restare è difficile. È lento. È imperfetto. Ma, pagina dopo pagina, diventa chiaro che è anche necessario. Perché senza chi resta, l’Italia frana. Letteralmente.
Montagne immaginarie ci invita a cambiare prospettiva. A smettere di inseguire l’altrove e guardare con occhi nuovi l’Italia che resiste. Quella delle montagne che non sono "immaginarie" ma dimenticate. E che proprio per questo sono oggi le più reali, le più urgenti, le più nostre.
Come scrive Sasso, restare non è un obbligo, ma una possibilità. Ed è proprio lì, in quella possibilità, che forse si gioca la sfida più bella del nostro tempo.
Immagine: Rafiee Artist (Unsplash)