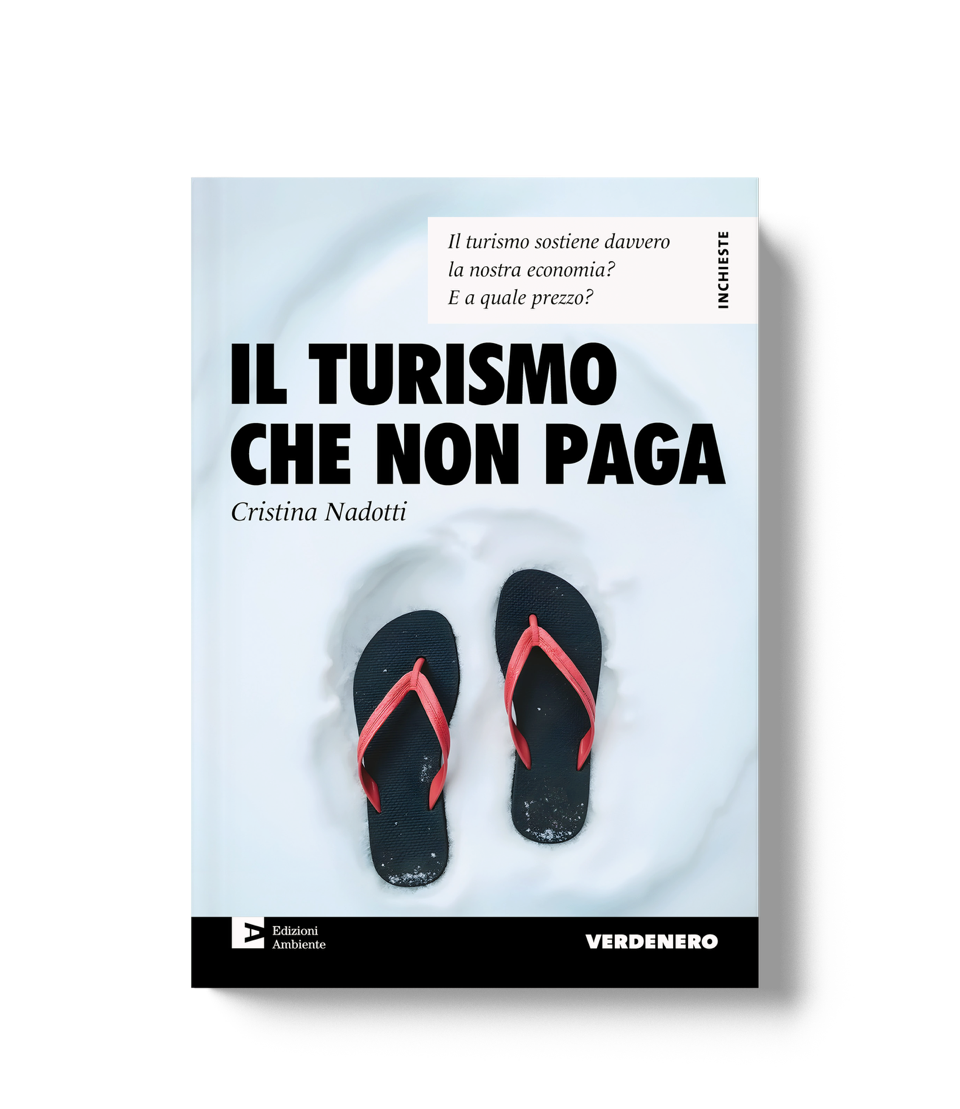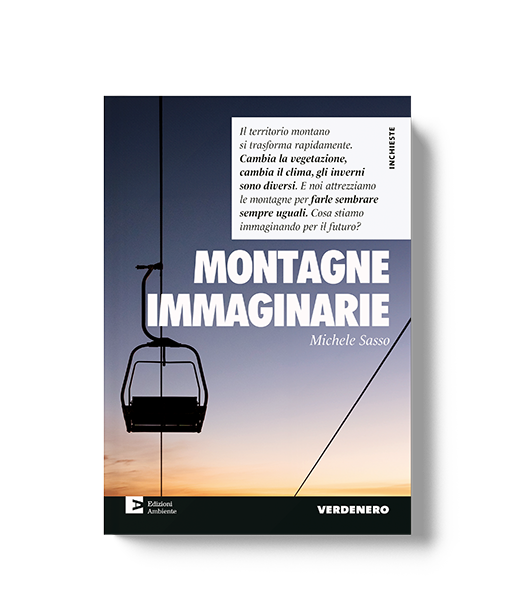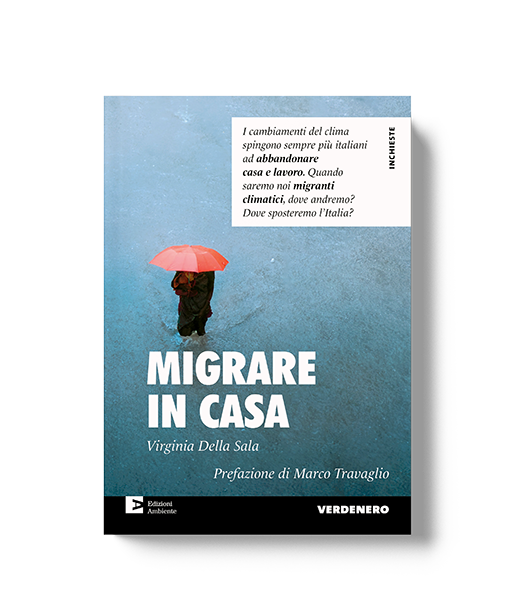Città da cartolina, vite in secondo piano
Cosa succede davvero nei luoghi che amiamo visitare? Cristina Nadotti ci porta dietro le quinte
Selfie, cocktail, tramonti e... costi degli affitti esorbitanti, lavoro precario e qualità della vita che si abbassa. Sotto la superficie scintillante di Airbnb panoramici e crociere paradisiache, si nasconde un malessere sempre più diffuso. È quello delle città che, da mete turistiche, si sono trasformate in scenografie viventi, piegate alle esigenze di chi arriva, consuma e riparte. Senza chiedersi cosa succede a chi resta.
Un giro fra le cronache recenti ci racconta come il fenomeno dell’overtourism sia diventato sempre più nemico di chi le città le abita 365 giorni l’anno. A Londra, nell’iconico quartiere di Notting Hill, famoso per le sue case pastello e per Hugh Grant con la camicia stropicciata, alcuni residenti esasperati hanno preso una decisione drastica: dipingere le loro abitazioni di nero. Le chiamano “black houses”. Un gesto di protesta silenzioso ma eloquente: “qui si vive, non si fotografa”. Via il colore, via le fioriere, via tutto ciò che c'è di instagrammabile. Troppi turisti, troppi influencer in cerca dello scatto perfetto, troppa invasione quotidiana.
A Barcellona, la ribellione ha preso toni più accesi: pistole ad acqua contro i turisti nei pressi degli hotel, manifestazioni di piazza, promesse delle autorità di chiudere 10.000 appartamenti turistici entro il 2028. La Spagna, con 94 milioni di visitatori solo nel 2024, rischia letteralmente di esplodere. Intanto, gli affitti per i residenti salgono alle stelle, la città si svuota di abitanti reali e si riempie di consumatori temporanei.
E in Italia? Siamo pieni di città che nei periodi di punta diventano invivibili per via dell’afflusso dei turisti. O, peggio ancora, di città che hanno perso la loro identità a favore di una recita, un maschera di cartongesso, diventando la scenografia perfetta per scatti social e aperitivi aesthetic. Senza autenticità, senza anima.
Basta dire “Venezia”. O meglio: basta dire “matrimonio di Jeff Bezos”. Il magnate americano ha trasformato la Serenissima in un set blindato per le sue nozze, spingendo un gruppo di attivisti a protestare contro la “feudalizzazione” di una città intera. “Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, puoi anche pagare più tasse”, recitava lo striscione gigante di Greenpeace steso in Piazza San Marco. Il gesto simbolico ha sollevato una domanda più scomoda: Venezia è ancora dei veneziani?
Sono solo alcuni esempi dalle cronache dell’ultimo mese, ma parlano chiaro. Il turismo, che troppo a lungo abbiamo visto come una gallina dalle uova d’oro, sta mostrando le sue crepe. Non sempre più turisti significa più benessere. Spesso vuol dire meno case disponibili, più traffico, più rifiuti, meno vivibilità. E più inquinamento: il settore turistico è tra i più energivori e climaticamente impattanti, tra voli low-cost, consumo di risorse e strutture extra-lusso che gravano su territori fragili.
A smontare il mito del “turismo che fa bene a tutti” c’è un libro inchiesta che questa estate sta facendo parlare di sé in tutta Italia: Il turismo che non paga, firmato dalla giornalista Cristina Nadotti e pubblicato all’interno della nostra collana VerdeNero Inchieste.
Il libro è un viaggio alla scoperta dell’altro volto del turismo, quello che difficilmente trova spazio nei nostri feed. Nadotti ascolta e poi dà voce a chi di solito non viene interpellato: i pendolari che non riescono più a salire su autobus pieni di trolley, i residenti dei borghi trasformati in luna park, i guardiaparco impotenti davanti all’assalto ai siti naturalistici, i cittadini costretti a emigrare dai centri storici diventati hotel diffusi.
Con dati, storie e voci dal territorio, Il turismo che non paga ci ricorda che l’industria dei viaggi non è neutra. È un’industria, appunto. E come tale ha un impatto. Ambientale, sociale, economico. Dall’invasione delle isole e delle spiagge al Sud al collasso delle stazioni sciistiche italiane, l’overtourism colpisce con forza l’Italia, per definizione uno dei paesi più gettonati fra gli itinerari turistici mondiali. Le conseguenze? Speculazione immobiliare, svuotamento dei centri urbani, consumo sfrenato di risorse e mancanza di regole adeguate.
Eppure, un cambiamento è sempre possibile. Il libro non è solo denuncia, ma anche proposta. Mostra alternative possibili e sostenibili. Un turismo più lento, regolamentazioni dei flussi, coinvolgimento delle comunità locali, consapevolezza nei consumi. Una cassetta degli attrezzi (come la definisce nella prefazione Ferdinando Cotugno) per ripensare il turismo senza demonizzare chi viaggia, ma partendo da chi ospita.
L’inchiesta di Nadotti è un invito a guardare oltre la cartolina. Perché dietro a ogni scatto perfetto, c’è spesso una realtà più complessa. E se vogliamo continuare a viaggiare, noi per primi, dobbiamo iniziare a farlo con rispetto e consapevolezza.