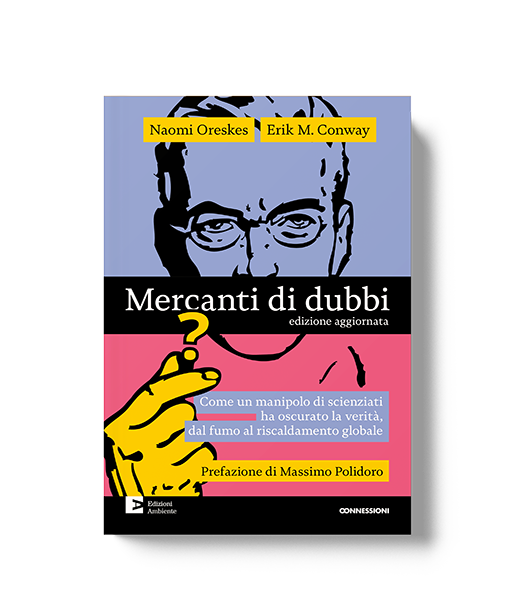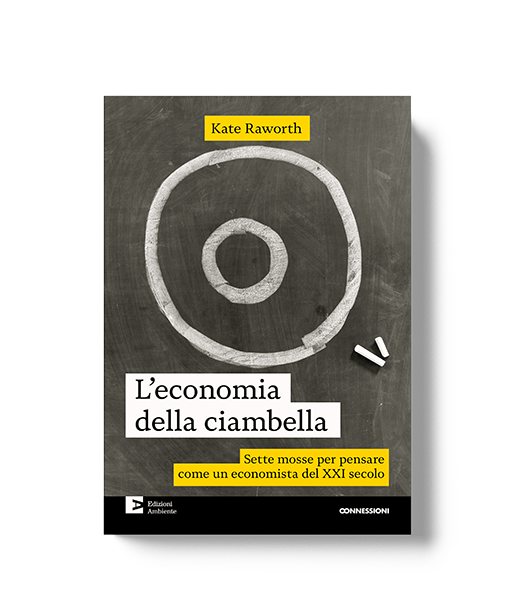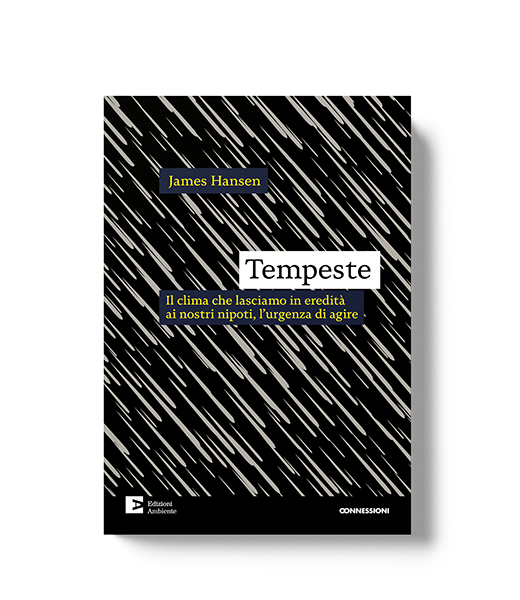Da geologa esploratrice a storica e filosofa della scienza
Intervista a Naomi Oreskes
Naomi Oreskes è professoressa Henry Charles Lea di Storia della Scienza e Scienze della Terra all’Università di Harvard e da oltre vent’anni la sua voce si leva forte e chiara in difesa della conoscenza scientifica. È autrice con Erik M. Conway del best seller internazionale Mercanti di dubbi. Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale di cui è appena uscita l’edizione aggiornata, oggi più attuale che mai. Il libro ripercorre i cambiamenti avvenuti dall’uscita della prima edizione quindici anni fa, dal dilagare del negazionismo e della disinformazione agli effetti del neotrumpismo, dalla retorica del libero mercato assoluto all’inazione politica di fronte alle crisi globali.
Mercanti di dubbi
Come un manipolo di scienziati ha nascosto la verità, dal fumo al riscaldamento globale
Naomi Oreskes, Erik M. ConwayL’intervista che vi proponiamo è stata pubblicata sul Magazine The Harvard Crimso, da noi tradotta e adattata.
Una delle sue principali aree di ricerca è l’agnotologia. Può spiegarci di cosa si tratta?
L’agnotologia è lo studio dell’ignoranza, e con questo intendiamo l’ignoranza in senso lato. Può essere un’ignoranza attiva, quindi di persone che cercano deliberatamente di ingannarci, come i pubblicitari, gli addetti al marketing, i propagandisti, l’industria del tabacco. Oppure può essere involontaria. Quindi, gran parte della mia ricerca riguarda il modo in cui, quando concentriamo la nostra attenzione di ricerca su un’area, possiamo trascurare o ignorare altre cose che ci circondano.
Qual è un’area importante in cui l’agnotologia è all’opera in questo momento?
Ovunque. Siamo continuamente bombardati dalla disinformazione e i social media non l’hanno creata, ma l’hanno certamente peggiorata.
Dei libri che ha pubblicato, qual è il suo preferito? E quale ritiene sia il più importante?
Oh, è facile, perché il primo libro è come il primo figlio. (Non lo dica ai miei figli.) Il mio primo libro è il mio preferito, perché credo che nel primo libro ci si metta il cuore e l’anima. Mercanti di dubbi pone una domanda che mi è ancora vicina e cara, anche a distanza di 20 anni: “Come fanno gli scienziati a sapere quando hanno abbastanza informazioni, abbastanza prove di qualità sufficiente per dire: ‘Sì, sappiamo che questo è vero’?”. È una domanda fondamentale per la verità scientifica.
[…] Non so dire quale sia il più importante, ma so qual è il libro che ha venduto più copie o che è più noto, Mercanti di dubbi. È il libro per il quale, se la gente sa chi sono, mi conosce. È successo proprio la settimana scorsa. Un uomo è venuto da me, chiaramente in età post-universitaria, con una copia malconcia in mano e mi ha detto: “L’abbiamo letto all’università, potresti firmarmelo?”. E questo fa sempre piacere. In altre occasioni mi hanno detto: “Sono diventato uno scienziato ambientale perché ho letto Mercanti di dubbi”.
In un’apparizione a “Facing The New Reality” per la cerimonia di apertura della Climate Week a New York, ha sottolineato l’intreccio tra i danni di un cambiamento climatico incontrollato e la crescita economica. Eppure, molte persone sono ancora molto legate all’attuale struttura dell’economia mondiale. È possibile investire nell’attuale sistema economico e allo stesso tempo combattere i cambiamenti climatici?
Credo che questa sia la domanda del momento. Avrei dovuto partecipare al Reuters Impact Summit di settembre. Non sono potuta andare per motivi personali, ma il panel a cui avrei dovuto partecipare era “Il capitalismo sostenibile è un ossimoro?”. E credo che questa sia davvero la domanda cruciale, perché se non riusciamo a trovare un modo per allineare la nostra economia con la nostra ecologia, allora saremo in guai seri. E lo stiamo già vedendo: quelli che gli economisti chiamano “costi esterni”, i danni dei cambiamenti climatici, i danni della distruzione della biodiversità. Queste esternalità aumentano di giorno in giorno, e oggi molto più che in passato abbiamo sotto gli occhi molti, molti miliardi di dollari di danni da eventi meteorologici estremi.
Secondo le stime del Fondo monetario internazionale, i costi esterni dei combustibili fossili ammontano a circa 1.500 miliardi di dollari ogni anno. Non direi di non dedicarci al settore bancario, finanziario o economico, ma di farlo e capire come modificare i nostri modelli per tener conto di tutto questo, in modo da non distruggere tutto ciò a cui teniamo. In fondo, qual è lo scopo della ricchezza? Dovrebbe essere vivere una bella vita, ma sempre più persone non raggiungono lo scopo a causa dei danni climatici.
Lei dice anche che dovremmo essere arrabbiati con le persone che ci hanno consapevolmente portato all’attuale crisi climatica e che stanno facendo profitti in questo modo. Come gestisce la sua rabbia?
La incanalo nell’azione. È il mio motto. Molte persone pensano che la rabbia sia negativa: “Non arrabbiarti”. Non sono d’accordo. Penso che la rabbia giustificata sia buona, ma deve essere dirottata nei posti giusti. Chi sono le persone responsabili di tutto questo? Dovremmo arrabbiarci con quelle persone e poi mettere quell’energia nell’azione: azione politica, azione sociale, azione personale.
Che cosa si sbaglia più spesso nella negazione dei cambiamenti climatici?
Quando ho iniziato a lavorare in questo settore, ormai 20 anni fa, la maggior parte delle persone pensava che la negazione dei cambiamenti climatici fosse basata sull’ignoranza, sulla mancanza di istruzione. La gente non capiva. Si trattava di analfabetismo scientifico. E quindi pensavano che se si fosse spiegata la scienza in modo più chiaro, si sarebbe risolto il problema. Abbiamo dimostrato che non è così. E infatti ci sono sondaggi che mostrano che tra i negazionisti del cambiamento climatico, tra le persone registrate come repubblicani, più sono istruiti e più è probabile che siano negazionisti. È una cosa molto triste da ammettere per un'insegnante, ma una maggiore educazione scientifica non risolve il problema.
Penso che ora il panorama sia più eterogeneo. Una delle cose che la gente sbaglia è credere che l’industria dei combustibili fossili possa essere un partner affidabile. Sono loro che hanno creato il problema. Per me, dire che dovremmo lavorare con loro sarebbe come dire a una donna maltrattata che dovrebbe cercare di fare pace con il marito.
In un lavoro in cui spesso si osservano le conseguenze negative dell’azione umana, quali sono le cose che le ridanno fiducia nell’umanità?
Niente. Scherzo. Vogliamo che ci siano cose positive. Vogliamo sentire storie a lieto fine. C’è tanta pressione, soprattutto negli Stati Uniti, per essere ottimisti. In un certo senso, questa domanda mi infastidisce molto. In un certo senso, distoglie l’attenzione dall’aspetto centrale, che è quello di riconoscere ciò che non va e ciò che deve essere risolto. La vera domanda dovrebbe essere: “Come possiamo risolvere questo problema nel modo più rapido ed efficace possibile?”. Ed è qui che cerco sempre di riportare la conversazione sulla rapida eliminazione dell’uso dei combustibili fossili.
Lei ora è professoressa nel Dipartimento di Storia della Scienza, ma ha avuto una formazione da geologa. In che modo questa formazione ha influenzato il suo approccio alla storia?
Credo che la mia formazione di scienziato della Terra influenzi la mia percezione dell’importanza della nozione di limiti planetari. A molte persone non piace l’idea dei limiti. Ancora una volta, soprattutto gli americani. Voglio dire, abbiamo un’iconografia così americana intorno all’idea di poter fare tutto ciò che si vuole. E ovviamente c’è qualcosa di attraente nel credere di vivere in un mondo pieno di possibilità, e non voglio essere io a dire: “No, in realtà non è così”. Ma in qualche modo profondo – un modo che, per me, ha radici nella mia formazione scientifica – c’è un limite a ciò che il pianeta può sopportare.
[…]
Ha collaborato con la compositrice Yvette Jackson per “Doubt”, un’opera musicale ispirata ai dubbi che circondano la scienza dei cambiamenti climatici. Quale ruolo pensa che la musica e l’arte debbano avere nel dibattito?
La maggior parte delle persone pensa che la scienza sia noiosa e poco interessante, oppure che sia al di sopra delle loro capacità e non sia accessibile. I dati scientifici raramente hanno un impatto emotivo sulle persone. In genere, se si forniscono solo aride informazioni scientifiche, le persone non agiscono, soprattutto se si chiede loro di cambiare modo di vivere e di pensare. Cosa spinge le persone a cambiare opinione o ad agire? Di solito in un qualche tipo di impatto emotivo, ed è qui che entra in gioco l’arte. Parte del modo in cui l’arte funziona - che si tratti di musica, di belle arti, di pittura, di scultura, di dramma, di teatro, di qualsiasi altra espressione - è perché c’è una connessione emotiva (a tale proposito si legga Ecolove, ndr).
Nel suo articolo su Scientific American, “The Public Wants Scientists to Be More Involved in Policy Debates” ("Il pubblico vuole che gli scienziati siano più coinvolti nei dibattiti politici"), lancia un appello per abbandonare la posizione “apolitica” degli scienziati e contribuire a dibattiti urgenti come quello sul controllo delle armi. Come immagina che si possa attuare con successo?
Voglio essere chiara: non sto chiedendo che tutti gli scienziati siano necessariamente coinvolti in dibattiti politici. L’articolo è nato dal lavoro che svolgo con la mia collega post-dottorato, Viktoria Cologna, che è qui in visita dall’Europa. Nel suo lavoro ha scoperto che molti uomini di scienza, soprattutto negli Stati Uniti, ritengono estremamente importante non essere coinvolti nelle decisioni politiche perché pensano che se lo facessero, sarebbero visti come politicizzati, non obiettivi, e quindi minerebbero la fiducia del pubblico nella scienza. Ma questa è una supposizione che molti hanno fatto senza fondamento di dati.
Una cosa che dico sempre è che la maggior parte degli scienziati, quando si tratta di pensare alla scienza, sono incredibilmente poco scientifici. Cologna ha scoperto che le persone che hanno partecipato al suo sondaggio, più in Germania che negli Stati Uniti, vogliono effettivamente che gli studiosi siano coinvolti nella politica. Considerano gli scienziati come persone che hanno informazioni importanti e utili, e quindi vogliono che siano coinvolti nella definizione delle politiche nelle aree in cui hanno competenza.
In che modo il suo interesse per il femminismo influenza il suo lavoro di storica della scienza?
La maggior parte del mio lavoro non riguarda esplicitamente la scienza delle donne e la maggior parte del mio lavoro non è esplicitamente femminista. Ma sono ovviamente una femminista perché, come ha detto Rebecca West, “altrimenti sono uno zerbino”. Come donna nella scienza a partire dagli anni ’70, ho certamente sperimentato discriminazione sessuale, condiscendenza, commenti inappropriati, insomma, tutto quanto, giusto? Quando ero alla scuola di specializzazione, ho letto molto di filosofia della scienza femminista. Queste pensatrici hanno influenzato il mio pensiero, in parte per contestualizzare la mia esperienza, in modo da capire che quello che stavo vivendo non era solo un problema personale. […] È davvero facile sentirsi isolate e incolpare se stesse e pensare che sia colpa mia perché non sto lavorando abbastanza. O è colpa mia perché indosso i vestiti sbagliati.
Ma no, non è colpa tua. Si tratta di un problema strutturale. Ha a che fare con i preconcetti. Avere questo tipo di quadro intellettuale è stato molto utile. Inoltre, mi ha fatto pensare al modo in cui i presupposti non influenzano solo il modo in cui trattiamo le altre persone. Influenzano anche il modo in cui comprendiamo il mondo in generale. Nessuno di noi è fuori da un contesto. E queste esperienze influenzano le domande che riteniamo importanti da porre, i tipi di risposte che troviamo convincenti, i tipi di prove che preferiamo.
[…]
Qual è la cosa che vorrebbe che la maggior parte delle persone sapesse di lei?
A volte, quando parlo con persone che non mi conoscono, faccio in modo di far notare che ero una geologa mineraria. Questo li sorprende e destabilizza alcune delle loro ipotesi sul tipo di persona che devo essere se sono una storica femminista della scienza che combatte la negazione dei cambiamenti climatici. Non sono anticapitalista. Non sono contro le miniere. Penso che tutti noi beneficiamo dei beni materiali che otteniamo dall’estrazione grezza di materie prime. Non vedo la Terra come un tempio che non può essere utilizzato. Ma ritengo che questo debba essere bilanciato e temperato con le cose di cui abbiamo parlato all’inizio di questa intervista. Ci sono limiti planetari e il consumo infinito ha conseguenze negative molto gravi.
Fonte intervista: Magazine The Harvard Crimson, 10 novembre 2023
Immagine: Jon Sachs