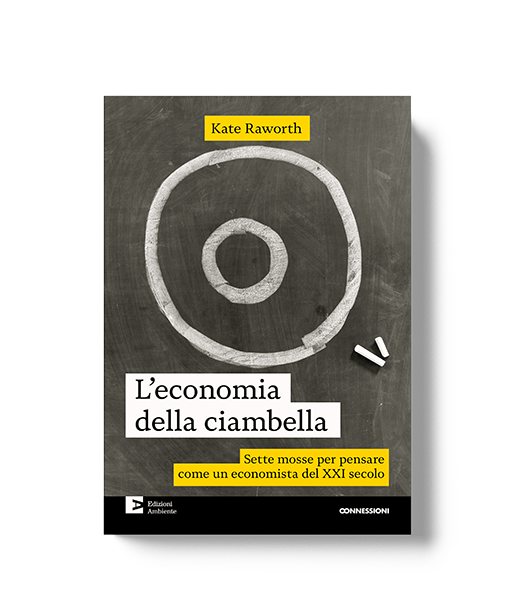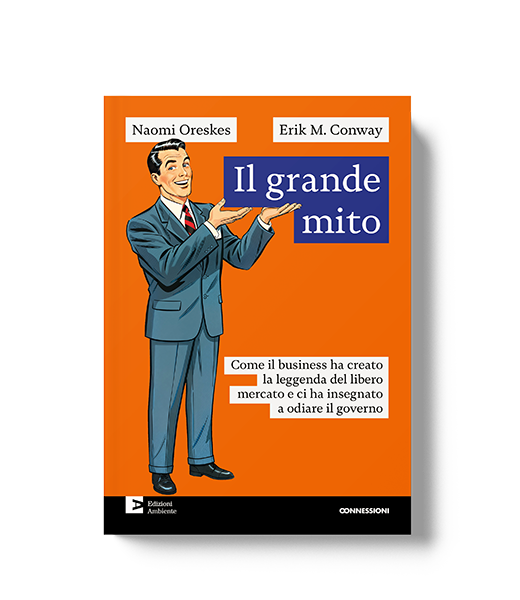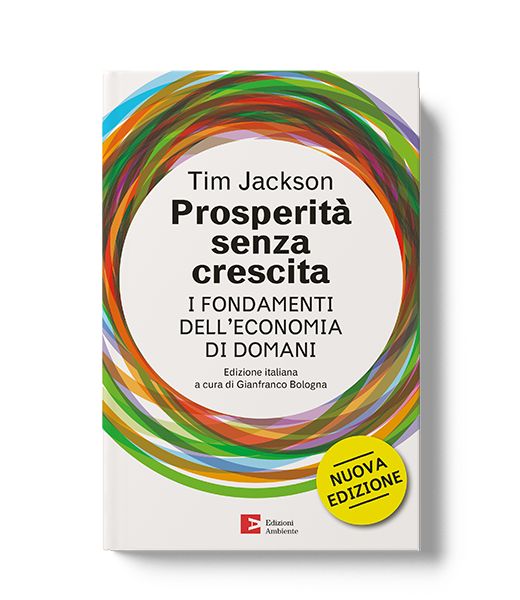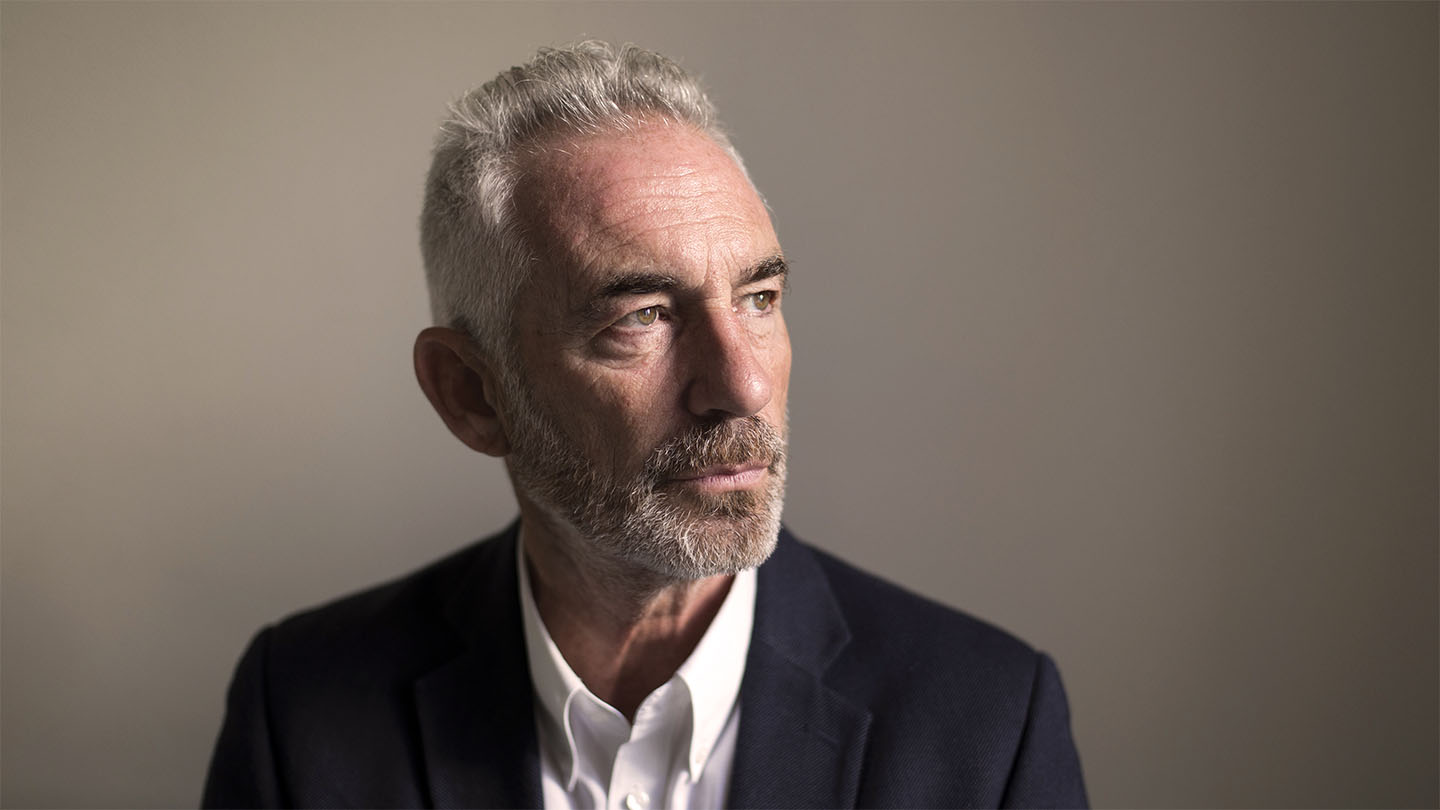Più Stato, meno mercato
Subito dopo l’attribuzione del Nobel per l’economia a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt per aver spiegato con i loro studi il ruolo dell’innovazione nella crescita delle economie e la funzione della distruzione creativa, Tim Jackson – autore per noi di Prosperità senza crescita – ha così commentato la decisione: “Possiamo forse considerarla come l'ultima, disperata ondata celebrativa di una scienza moribonda e in declino? O dovremmo vederla come un requiem per l'umanità? Qualcuno può spiegarmi come un'ossessione irriducibile per la distruzione creativa e un disinteresse quasi totale per i limiti del pianeta finito su cui tale distruzione sta avvenendo possano essere celebrati come un lavoro innovativo e meritevole di un premio su 'una delle più grandi questioni delle scienze sociali'? La questione più importante, a mio avviso, è come una tale follia abbia potuto avere una presa così forte sulla nostra politica, sulle nostre istituzioni e sulla nostra economia”.
L'economia della ciambella
Sette mosse per pensare come un economista del XXI secolo
Kate RaworthGli economisti premiati non sono acritici celebratori di pratiche distruttive o beatificatori dell’innovazione a prescindere; nelle loro dichiarazioni testimoniano la consapevolezza di come tali processi, se non gestiti, possano produrre pesanti conseguenze negative sia sul versante sociale sia su quello ambientale. La reazione a caldo di Jackson è però spiegabile in una fase storica dove concetti come innovazione e distruzione creativa si inseriscono in un contesto di crescenti disuguaglianze – diventandone spesso vettori importanti – e dove lo sbilanciamento nel potere tra politica, che dovrebbe gestire gli impatti, e attori economici appare quanto mai vistoso.
Inoltre, come amano fare i media e in generale proprio la politica, ci si impadronisce senza farsi troppe domande di un paio di termini – innovazione e distruzione creativa – per usarli anche contro le convinzioni di chi ne ha studiato le dinamiche e gli effetti tanto da meritare un riconoscimento così mediaticamente importante come il Nobel.
Ma proprio per questa caratteristica del premio, la sua “notiziabilità”, valorizzare la sempre crescente produzione critica verso lo status quo dell’economia forse avrebbe avuto un maggiore significato, guardando a chi elabora idee e modelli in grado di innovare l’economia e la società verso quello “spazio sicuro e giusto” per l’umanità che dovrebbe esserne l’obiettivo. L’unico moralmente accettabile, per realizzare quella visione di un’economia “distributiva e rigenerativa” che Kate Raworth definisce in L’economia della ciambella.
Sarebbe stato un Nobel più coraggioso, perché tra l’altro da premiare c’è davvero tanto, e ovviamente non solo tra gli autori nei nostri libri. Non limitandosi all’ambito stretto degli studiosi di discipline economiche, si potrebbe estendere il campo per esempio agli storici della scienza che osservando “da fuori” – da un diverso ambito disciplinare – la formazione e diffusione di costrutti teorici che spiegano, supportano, propagandano pratiche e politiche economiche, ne svelano l’essenza e gli effetti. Naomi Oreskes ed Erik Conway lo fanno nel nuovo lavoro Il Grande Mito che ricostruisce minuziosamente fasi, strategie e attori della creazione del mito del libero mercato. Mito, come molte delle presunte “leggi” dell’economia che in un perfetto rovesciamento della realtà consideriamo al pari di meccanismi naturali, mentre ce ne freghiamo allegramente di come proprio l’applicazione di queste vada a infrangere leggi, queste si immutabili e belle solide, della fisica.
Come si costruisce una favola più solida delle leggi della fisica? In tanti modi, anche sorprendenti, con strumenti e linguaggi a volte apparentemente innocui che Oreskes e Conway non trascurano di documentare, dove il target da colpire è l’autorità delle istituzioni democratiche e la loro possibilità di intervenire nell’economia per orientarla verso l’interesse della collettività, e non del singolo o di un’élite. Cosa che dovrebbe (condizionale d’obbligo) essere la funzione dei governi.
Tutto questo ci riguarda o è solo un problema degli Stati Uniti? Chi si ricorda di uno slogan che qui in Italia qualche decennio fa ha goduto di un certo successo ma che, soprattutto, da allora è diventato un dogma per governi anche di diverso colore? Era “Meno Stato, più mercato”. Quella leggenda, quindi, ci riguarda eccome e ne stiamo facendo sempre di più le spese. Ma sembriamo contenti così. Potenza delle narrazioni.
Immagine: Jingxi Lau (Unsplash)