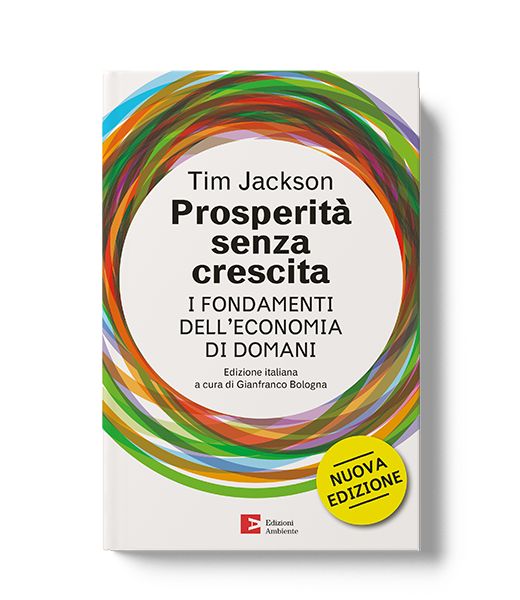La nuova economia
Intervista a Tim Jackson, ottobre 2017
In Prosperità senza crescita Tim Jackson affronta in maniera estremamente lucida un tema che non può più essere rimandato: creare prosperità per il genere umano, senza dilapidare ulteriormente le risorse planetarie e appianando le disuguaglianze sociali. Ovvero un’idea alternativa di economia, oggi ancora basata sulla crescita infinita.
La prima edizione del suo libro nel 2010 nasce da un fatto perlomeno curioso. Quale?
Questo libro nasce da un rapporto commissionato dal governo britannico. Si trattò di una consulenza che feci sulla sostenibilità per una commissione governativa. L’idea era quella di rivisitare l’idea di crescita economica, in particolare del conflitto tra la crescita infinita e l’ambiente. Un concetto già espresso nel ‘Rapporto sui limiti dello sviluppo’ redatto dal Club di Roma negli anni ’70. Prosperità senza crescita cercò di affrontare queste tematiche. Mentre lo stavo scrivendo la crisi finanziaria iniziò a farsi sentire. La cosa interessante è che il rapporto uscì durante il G20 che si tenne a Londra nel 2009, quando i Grandi della Terra si riunirono proprio per far ripartire l’economia. Come racconto anche nel libro, al governo il rapporto non piacque, lo stesso primo ministro Gordon Brown ne fu molto dispiaciuto. La stampa inoltre non ne parlò. Poi pian piano il rapporto divenne molto popolare, tanto che diventò un libro pubblicato in 17 diverse lingue, tra cui anche l’italiano.
Prosperità senza crescita
I fondamenti dell'economia di domani
Tim JacksonIl libro suscitò molto interesse. Probabilmente perché anche le persone cominciarono a chiedersi come evitare che una crisi di questa portata potesse accadere di nuovo. È così?
La crisi economica ha avuto un profondo impatto su come pensavamo l’economia e la politica. Ha portato alla luce le disuguaglianze, le profonde differenze tra i più ricchi e i più poveri. Ciò che è interessante è che tutto questo è arrivato in un momento durante il quale tutto il mondo doveva decidere di agire nei confronti del cambiamento climatico. Nel 2009 alla Conferenza sul clima di Copenaghen ci si era prefissati dei target specifici, in particolare per le nazioni sviluppate. È stato chiaro che se volevamo affrontare il cambiamento climatico avremmo avuto bisogno di investimenti. Ma per avere investimenti avremmo dovuto avere istituzioni finanziarie in salute. E questa era l’ultima cosa che avevamo. Cosa che sta continuando anche oggi. Certo ora abbiamo una finanza più stabile, banche più forti, ma continuiamo a non aver sufficienti investimenti nelle tecnologie per affrontare i cambiamenti climatici, anche nove anni dopo la crisi. Ed è questo che mi ha spinto a fare una revisione del primo libro.
La crisi finanziaria, l’austerity, le difficili condizioni economiche di alcune nazioni dell’Europa. D’altra parte abbiamo invece la crescita di economie come Cina e India. Cosa è cambiato in così pochi anni? Cosa ci dobbiamo aspettare?
Molte cose sono cambiate. Viviamo in un mondo completamente diverso. La rottura era già nell’aria ancora prima della crisi finanziaria. Il modello stava già cadendo a pezzi: l’idea di un’economia che promuove sempre più i consumi, se necessario creando sempre più debito, non funziona. Era già in difficoltà nel 2006. Quando arrivò la crisi finanziaria, secondo me abbiamo avuto una visione naif di quelle che sarebbero state le implicazioni. Sembrava che tutto potesse tornare come prima. Ma il modello non funziona: crea disuguaglianze, crea problemi ambientali, crea un sistema finanziario instabile. Non sta migliorando la vita delle persone, rendendole più felici. Anzi le sta rendendo infelici. Pensiamo all’aumento delle malattie legate agli stili di vita, come l’obesità. Sono prodotti di un modello che non funziona più. E non possiamo risolvere questi problemi solo con la tecnologia, o con l’austerità, che è stato un esperimento orribile. L’austerità ha lasciato indietro milioni di persone. E ciò ha fatto crescere i movimenti populisti, sia a destra sia a sinistra, che rivendicano una sorta di speranza per il futuro, in qualsiasi modo. Se necessario anche uscendo dall’Europa, come accaduto in Gran Bretagna. Questo è periodo straordinario della storia perché l’intero consenso nei confronti del capitalismo e della democrazia sta crollando. Certo abbiamo la tecnologia, l’economia circolare, le energie rinnovabili. Quale dovrebbe essere quindi l’economia nella quale dobbiamo investire?
Nel frattempo l’1% della popolazione possiede il 50% della ricchezza mondiale. Dovremmo ridistribuire la ricchezza? E come?
Ciò che sta succedendo è che un numero sempre più piccolo di persone possiede la maggior parte degli asset e dei profitti che questi comportano (per asset si intende ogni entità materiale o immateriale suscettibile di valutazione economica di proprietà di un’azienda, ndr). Nel frattempo la vita lavorativa delle persone diventa sempre più insicura. Il lavoro retribuito è un costo. Ciò che il capitalismo fa è di ampliare sempre più questa differenza, piuttosto che ridurla, a meno che non vengano ridistribuiti i guadagni e gli asset. E per fare ciò ci sono tre modi. Uno è quello di aumentare la tassazione nei confronti della parte più ricca della popolazione. Ma questa soluzione è come mettere un cerotto quando si sta grondando sangue. Potrebbe funzionare, ma non cambierebbe necessariamente le disuguaglianze nel possesso degli asset. Ci sono poi altri sistemi, ne esistono degli ottimi esempi. Per esempio far partecipare i lavoratori al capitale aziendale: in questo caso la proprietà dell’impresa è in mano ai lavoratori, ed è così possibile ridistribuire la proprietà dei beni e dei capitali. La terza possibilità è la protezione del lavoro salariato: se rallentassimo leggermente la sostituzione del lavoro con la tecnologia e proteggessimo il lavoro salariato, automaticamente potremmo ridistribuire la ricchezza, perché ridurremmo la differenza tra salario e profitto.
Il mondo accademico è concorde nell’affermare che una crescita infinita in un mondo finito è praticamente impossibile. Perché la politica e parte del mondo economico faticano ad accettare questo concetto, così chiaro agli ecologi?
Perché abbiamo un modello basato sulla crescita. Pensiamoci un attimo. Da una parte sappiamo di vivere in un mondo dalle risorse definite, dall’altra abbiamo un sistema economico che ci dice che più consumiamo, meglio è. Gli ecologi ci dicono che non possiamo espanderci oltre al nostro pianeta, mentre gli economisti rispondono che la tecnologia potrà rendere efficienti tutti i processi, impiegando meno risorse. È il cosiddetto decoupling (disaccoppiamento), ovvero il trucco magico con il quale potremmo realizzare qualsiasi bene o servizio in maniera più efficiente. Ma quanto è realistica questa idea? Quanto velocemente dobbiamo sviluppare nuova tecnologia perché questo trucco magico funzioni? Abbiamo degli obiettivi climatici chiari, sappiamo quanta CO2 possiamo emettere, sappiamo quanto potrà ancora crescere l’economia. Quale dovrebbe essere dunque l’efficienza tecnologica e quanto può ancora crescere? Certo negli anni c’è stato un aumento dell’efficienza, ma ciò che stiamo vedendo ora è che il consumo di risorse non diminuisce quanto si era previsto. Negli ultimi anni le emissioni si sono sì stabilizzate, ma non ridotte. Tutto questo indica che il decoupling non è sufficiente e non sta funzionando.
Cosa pensa del concetto di economia circolare? Può dare nuova linfa alla crescita?
L’economia circolare è un’idea fantastica, come il pensiero di rendere tutto il sistema economico più efficiente, ma non è sufficiente. E non affronta il problema centrale dell’economia. Se pensiamo che l’economia circolare possa dare nuova linfa alla crescita economica, rendiamo tutto più difficile. Cioè se vogliamo che l’economia cresca sempre più velocemente, dovrà diventare sempre più circolare, più efficiente. E questo è estremamente difficile. Ciò di cui abbiamo bisogno è un altro tipo di economia. Dobbiamo rivedere i concetti di impresa, di lavoro, di investimento, di denaro. Da un punto di vista meramente capitalistico, l’impresa non è altro che un processo per massimizzare i profitti, per estrarre materie prime il più velocemente possibile, trasformarle e venderle al prezzo maggiore possibile, per poi buttarle via. Ma questa è un’idea sbagliata di ciò che dovrebbe essere l’impresa, che dovrebbe invece provvedere a fornirci ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere una qualità migliore di vita. Ecco perché dobbiamo ripensare il modello di impresa. Vogliamo un’impresa che continui a produrre secondo il modello lineare? No, vogliamo produca in maniera più circolare. Vogliamo che fornisca sempre più prodotti? No, vogliamo dare alle persone una migliore qualità di vita: quindi assistenza sanitaria e sociale, educazione, conservazione degli ecosistemi, riqualificazione urbana. Ovvero degli investimenti nella società, nella cultura, nelle capacità delle persone di convivere. Si tratta di un compito estremamente specifico. Dovremmo iniziare a pensare, piuttosto che a un sistema di produzione di massa, a uno in grado di fornire prodotti e servizi di cui le persone abbiano realmente bisogno a livello locale, per incrementare la loro qualità di vita. Si tratta di una questione estremamente interessante, perché si collega al tema degli "asset bloccati". Si tratta di un termine finanziario che parte dall’assunto che, se vogliamo affrontare il problema dei cambiamenti climatici, non possiamo continuare a utilizzare le fonti fossili. Ciò significa che continuare a investire nelle esplorazioni petrolifere, creerà nel tempo degli investimenti "bloccati", ovvero investimenti che rischiano di diventare privi di valore nell’immediato futuro. Se vogliamo raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio, per quanto ancora saranno possibili questi investimenti, ancora 20 anni? Mentre gli investimenti pensati per migliorare la società avranno certo un minor margine di profitto, ma dureranno per sempre.
Recenti studi scientifici hanno dimostrato come solo 90 grandi compagnie siano responsabili del 70% delle emissioni di CO2. Gruppi potenti, capaci di condizionare l’opinione pubblica e la politica. Perché dovrebbero voler cambiare modello economico?
In particolare per due ragioni. La prima è che se i governi mettono in atto una legislatura pensata per affrontare i cambiamenti climatici, tutti gli ‘asset bloccati’ o ‘incagliati’, per i successivi 20-30 anni non sarebbero più buoni investimenti. E questo dimostra la battaglia in corso tra la politica e le persone comuni per affrontare i cambiamenti climatici. L’esempio interessante è quello della Norvegia, che ha disinvestito tutti gli asset basati sul carbone dal fondo sovrano. E questo è un messaggio potente per queste compagnie: "Il futuro è leggermente diverso da come ve lo aspettate". L’altro motivo è che il mondo creato finora è un mondo nel quale l’instabilità sociale è il problema maggiore che la politica si trovi ad affrontare. E questo fa avanzare i movimenti populisti, più difficili da controllare e capaci di destabilizzare la politica. Governi così orientati non investirebbero più nell’industria dei combustibili fossili, perché impegnati ad affrontare disordini e problemi sociali. Sono convinto che almeno una piccola parte di questi grandi gruppi si stia rendendo conto che l’instabilità sociale e politica sia in grado di danneggiare il loro successo economico.
Articolo pubblicato su Materia Rinnovabile, n. 18, Edizioni Ambiente, settembre-ottobre 2017